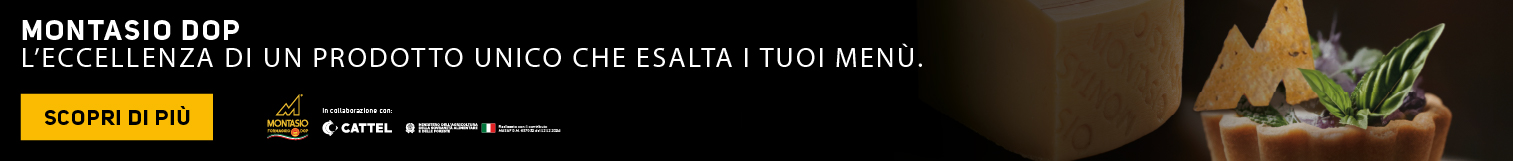La Storia
C’è un po’ di alea e un po’ di vertigine, nel gioco del vino di Frank Cornelissen, grande solista dell’Etna. Il senso del rischio, la sfida con se stessi, la maniacalità intransigente, il coraggio e la capacità di svuotarsi e rabboccarsi al ritmo delle anfore, quasi un moto emetico per restare vivi, che può ricordare Josko Gravner. Sono vini che non smettono di buttare alcol sul fuoco, incensati, biasimati, fraintesi. Comunque, irriducibilmente se stessi, come irriducibile è il loro autore, vignaiolo, ambientalista, degustatore non meno inquieto del vulcano che gli borbotta incessantemente sotto i piedi.

Sarà per questo che ha lasciato le Fiandre dove era cresciuto, figlio della direttrice di un istituto alberghiero e di un gourmet smaliziato, che lo aveva svezzato ai grandi classici francesi. “Ma i vini italiani li ho scoperti qua, perché in Belgio non arrivavano. Il Brunello in particolare: una rivelazione”. Studi in lingue (che “apparentemente non c’entrano niente, ma portano verso altre culture”), poi la carriera da broker del vino e la decisione di cambiare vita e fare il vignaiolo sulla Costa d’Oro. “Il mio primo mestiere però me l’ha insegnato nonna Clara: il sarto. Ancora oggi mi piace modificare le tende da alpinismo. La montagna è la mia passione, perché quando ti esponi alla morte, sviluppi un senso altissimo della vita. Senza morte la vita non ha valore”. Anche questo è Etna, anche questo è territorio. Ha qualcosa a che fare col vino? “Quando scegliamo di non trattare corriamo un rischio calcolato, come scalare una parete difficile. Certo se sei preparato, il pericolo diminuisce. Ma occorre una perfetta conoscenza di sé; oltre alle capacità fisiche, ci vuole l’organizzazione. E sei sempre a confronto con te stesso”.

Il risultato di questa scalata è il Magma, leggendario Etna rosso che ha rotto ogni schema, la cui bottiglia è dipinta dalla moglie Aki con calligrafia giapponese; tutt’intorno una coorte di 12 cru, i MunJebel. Ogni anno ne escono 6 o 7, il resto dell’uva finisce nel rosato o nel vino base, se non diventa addirittura concime.
Come è andata la vendemmia?
L’uva è dentro, ma non so. I vini raccontano sempre un’altra storia. Vedremo dopo le fermentazioni. Posso già dire che non è una grande annata. Se possibile non tratto, ma negli ultimi anni l’andamento è stato molto strano. Il 2012 è stato l’ultimo anno in cui abbiamo evitato zolfo e rame, perché nel 2013 e nel 2015 c’è stata troppa acqua, forse nel 2016 potevamo saltare, ma nel 2017 è caduta tanta neve. Siamo in biologico e seguiamo il calendario: quando le malattie si manifestano, è già troppo tardi. Ma nessuno può sapere di preciso come sarà il tempo. Il vino non è standardizzabile: è la personalizzazione totale, ogni zona è diversa, i vitigni, le annate, i lieviti che cambiano… Quest’anno per esempio la fermentazione è più veloce, a temperatura invariata. Ma un vino del territorio richiede lieviti indigeni, non in bustina come si fa con la birra. Già ce li abbiamo, perché buttare soldi?

Queste anomalie dipendono dai cambiamenti climatici?
Tutti ne parlano e sono innegabili. Anche se il tempo è bello, resta strano. In 19 anni di vendemmie, compiuti quest’anno, non ho mai visto per 3 settimane di fila, quasi tutto il mese di ottobre, un vento dominato dall’umidità, legato a una circolazione di aria africana. Da quando sono arrivato nel 2001, abbiamo sempre avuto un vento più continentale, asciutto. Ma la tramontana quest’anno è andata in vacanza. Umidità di notte, brina la mattina sull’uva, poi bel tempo. Non mi lamento, ma c’è da interpretare l’annata. E le piante ne risentono, non stanno bene. Sono bloccate nel loro ciclo vegetativo, con differenze di maturazioni fenoliche. Ogni anno c’è qualcosa di particolare, non necessariamente negativo. E bisogna sfoderare l’inventiva. Al tavolo di selezione abbiamo scartato non so quanta uva. Ho sempre avuto prezzi relativamente alti, è facile criticare, ma bisogna capire cosa ci sta dietro.

Come sono cambiati i tuoi vini negli anni?
Ultimamente ci penso spesso. Vedo tre fasi. La prima è intellettuale: il concetto era la roccia liquida, cercavo il territorio oltre il frutto. Perché era stufo dei vini degli anni ’90: i Barolo di una volta, fatti in botte grande, con una certa austerità e tannicità, improvvisamente erano prodotti in barrique, che significa vaniglia e dolcezza, con uva stramatura e macerazioni brevissime. Il frutto sul Barolo, concettualmente un’antitesi. Erano talmente strafatti che il territorio diventava impercettibile. Anche i Médoc, che avevano una certa austerità e tannicità, erano diventati irriconoscibili, sembravano vini di Saint-Emilion o Pomerol. Tutta frutta rotonda, quasi dolce, che nel Médoc, a Saint Julien e Pauillac non si era mai vista. Alla cieca pensavo: non capisco più niente, sono diventato pessimo. Poi ho intuito che il problema non ero io, ma una generazione educata al classicismo del vino, con la riconoscibilità dei luoghi, che non contava più niente. Era tutto scombussolato. Da questa consapevolezza sono partito per arrivare alla roccia liquida, la massima espressione del territorio. Fino al 2005 ho fatto questi vini molto intellettuali, per sottrazione, preossidati ma tesi al miglioramento continuo. Poi sono cominciati i primi problemi con le anfore, che ho usato fino al 2008, e ho cercato più freschezza, con altre tecniche e materiali in cantina. I vini sono migliorati, ogni tanto le autolisi davano qualche problema di riduzione, ma con gli anni passava e diventavano perfetti, per quanto rustici. Il terzo periodo è iniziato nel 2014, con la ricerca di maggiore linearità e potenziale di invecchiamento. Lavorando sulla precisione, però, diventa più difficile la longevità, perché nello sporco c’è tanta roba che protegge, anche se fa sclerare i profumi. Come una macchina sotto il fango, che salvaguarda la pittura. Per centrare l’obiettivo sono necessarie una grande materia prima, che abbiamo sempre avuto grazie alle basse rese, e qualche accortezza in vinificazione. Laddove per mancanza di tecnica e tecnologia i vini prima prendevano 100 di ossigeno, oggi in scala ne prendono 20, senza riduzione. Siamo diventati più bravi, anche grazie alle capacità finanziarie. Noi investiamo costantemente per migliorarci. Ogni 3 anni cambiamo tutto, l’imbottigliatrice, la diraspatrice, abbiamo tre pompe per piano. Io sono appassionato di meccanica: gli attrezzi di cantina sono il mio hobby, li amo, li modifico, li smonto, li rimonto…

È su questo che stai lavorando?
Quello che mi interessa in questa fase è bere i grandi classici per capire a che punto sono e se il mio palato è cambiato. Mi piacciono gli stessi vini di un tempo, sia a Bordeaux che in Borgogna, e sento che mi sto avvicinando a quel classicismo in una chiave che potrei definire neoclassica: sono vini con un’apertura, una profondità, una generosità. L’unico punto interrogativo è la longevità. Un grande Bordeaux deve avere almeno 20 anni, mentre un Borgogna lo apro prima del quindicesimo. Sarebbe interessante avere almeno quel percorso. Penso che ci possiamo arrivare, lavorando sulla vinificazione. Serve a questo anche il magazzino che sto costruendo sottoterra, in modo che le bottiglie arrivino sul mercato quando sono più aperte. Ma la precisione e la tenuta nel tempo sono valori difficili da conciliare, quando si lascia spazio al percorso spontaneo del vino. Nell’ossidazione si perde la precisione, come accade alle persone. Più vecchio vuol dire più saggio, ma anche meno preciso.

Perché hai scelto l’Etna per fare vino?
L’ho scelto perché potenzialmente è un grande terroir. Volevo cambiare lavoro e stavo cercando il posto giusto in base a una serie di prerequisiti: il freddo in inverno, ma non eccessivo, vecchie vigne preferibilmente a piede franco, un clima continentale asciutto. E qui c’era tutto. A Modica con Giusto Occhipinti avevo bevuto una bottiglia alla cieca da Beppe Barone. Pensavo fosse Gattinara, perché ricordava il nebbiolo nelle annate calde. Mentre gli altri vini erano acidi e tesi, perché venivano dal lato est. Allora ho preso la macchina e sono venuto a Randazzo, ho cercato Calderara e ho visto le piante vecchie, i muretti a secco, al bar mi hanno raccontato che si vendemmiava a fine ottobre. ‘Cavolo! È qui, ho capito tutto’, mi sono detto. Avendo lavorato in Giappone, ho sempre mirato all’essenza, eliminando il superfluo. Quindi sono partito dal legno. Da queste parti si usava la botte di castagno, ma io volevo andare oltre, quindi le anfore e poi la vetroresina, contenitori neutri. Costruire una casa in Giappone richiede grande tecnica, i muri stessi sono un’opera d’arte, senza bisogno di quadri. È la materia che diventa bella, ed è quello cui ho sempre aspirato.
A fare vino hai imparato da solo?
Sì, non volevo essere influenzato. Fare vino non è così difficile, all’inizio procede da solo, poi va seguito. Ma non è fantascienza. Se invece vuoi fare grandi vini con una linearità, una personalità, pochissimi difetti comunque accettabili, bisogna investire e studiare. Parlo di vini che seguono un concetto, un’idea, non il caso. Personalmente ho cominciato senza aspettative, assaggiavo e mi piaceva. Senza punti di riferimento.

Nemmeno i piemontesi erano un riferimento?
Ho venti particelle in queste vigne e vedo che alcune danno vini tendenti al pinot nero. La maggior parte però ha un’affinità con il nebbiolo. Un tannino non ruvido come l’aglianico o il sagrantino, ma fine e fitto, che diventa dolce con l’invecchiamento; talvolta anche la foglia secca, che è un tocco da Barolo. Nelle annate classiche, però, il nerello si approssima piuttosto a un Gattinara o a un Barbaresco. Sono un appassionato di nebbiolo, molto più della Borgogna.
È il più grande vino del mondo?
Dipende dall’età. Da giovane sei attratto dal frutto perché l’approccio è più facile, quindi il pinot nero. Ma invecchiando si cercano altre cose, determinate saggezze. Il nebbiolo vinificato sul frutto è di una noia completa. Ma un Barolo Monprivato ’70 di Mauro Mascarello, un Barbaresco Santo Stefano di Neive ’89 di Bruno Giacosa etichetta rossa sono vini da capogiro. In un Riesling tedesco più della mineralità risalta la spinta acida, mentre i francesi sono rotondi, armoniosi, omogenei. Un grande nebbiolo invece ha il tannino, perché c’è più personalità, anche in cucina. È questa la forza dell’Italia.

A proposito di Riesling, qual è il tuo rapporto con i bianchi?
Amo i bianchi, ma non quelli dell’Etna. Sono acqua, alcol etilico e acido citrico. Basta stappare un Pinot-gris d’Alsace, che costa magari 12 euro la bottiglia: è meglio del miglior bianco dell’Etna. Oppure una Vitovska del Carso. Il mio bianco, il MunJebel, lo faccio come sfida tecnica, per imparare la gestione dell’ossigeno, la temperatura, il gioco con la riduzione, che sui rossi è troppo pericoloso. Ma sul rosato può starci. Il Susucaru è un vino nato per caso, ma interessante e radicato in zona, ha carattere, rappresenta me e la mia visione, piuttosto prossima a un rosso. Sui bianchi invece direi che siamo in mezzo a una strada: dobbiamo definire la tecnica e perfino i vitigni, non necessariamente il carricante; stringere le maglie del disciplinare, perché la forcella è troppo ampia. Ora come ora il miglior bianco dell’Etna è uno chardonnay. Ma la mia sfida non è quella, perché non mi basterebbe un’altra vita. Ho ancora 20 vendemmie davanti nel pieno delle forze, sapendo che ogni decennio c’è una grande annata. Non mi resta molto da fare.

Questa precisione del dettaglio è un retaggio delle tue origini fiamminghe? Penso alle nature morte, che tra l’altro hanno sempre un significato simbolico.
Può darsi, ma non voglio perdere la visione generale, in una società sempre più focalizzata sulle singole parti. Amo la pulizia e la meccanica; ma la scienza senza coscienza è pericolosa e anche confusionaria. Per me finisce quando inizia il lievito. Non voglio sapere cosa fa là dentro. Ci metto semplicemente il naso: se non puzza, va bene. Perché inizia il divino, è la vita. Se invece comincio a intervenire e a fare il creatore, qualcosa non quadra, perché faccio parte della creazione. Il vino è sempre stato una bevanda sacra, dall’eucarestia in avanti. Negare questo è negare tutto, la sua storia e la sua essenza. Io credo in Dio, ma non so chi sia. Può essere il mio cane lupo, che è appena morto; può essere il mondo vegetale o la vigna in cui produco Magma, dove sto bene, sento una vibrazione. Ha un’energia, una posizione, il vino che esce fuori è speciale. Certo non si ottiene automaticamente. All’inizio la gente di qui non poteva capire che con rese bassissime, un certo lavoro di pulizia e di selezione si potessero ottenere risultati del genere. Ma un grande vino ha bisogno dell’uomo, il terroir implica il vignaiolo, che deve essere incluso. Deve viverci, deve starci. E io mi sento italiano, anzi siciliano.
E qui veniamo alla sostenibilità.
Le aziende piccole inquinano più delle grandi, che sono obbligate per ragioni di immagine a investire. È uno dei motivi per cui voglio crescere. Perché con 20 o 30mila bottiglie di produzione puoi farti una vita dignitosa, ma non hai nessun margine per investire o restituire qualcosa al mondo circostante. Mentre io voglio saldare il mio debito. Per esempio ho appena firmato un compromesso: 6 ettari saranno piantati a vigna e almeno 2 a castagneto. La forestale mi prende per matto, ma con tutti gli incendi che ci sono stati, anche attorno a Barbabecchi, fra poco vivremo nel deserto. Cambia l’aria e questo si avverte nel prodotto finale, in termini di freschezza.

I tuoi vini sono naturali?
Per me il vino non è né naturale né umano, ma culturale. In vigna trovi la vite, che viene coltivata dall’uomo in simbiosi con la natura. Ma l’uva va interpretata: se la dividiamo a metà, io e te otterremo risultati diversi. Chi va a fare danni con la chimica in vigna, invece, crea danni al prodotto finale e intorno alla vigna stessa. Alla fine il vino migliore è quello che manifesta più rispetto per l’uva.