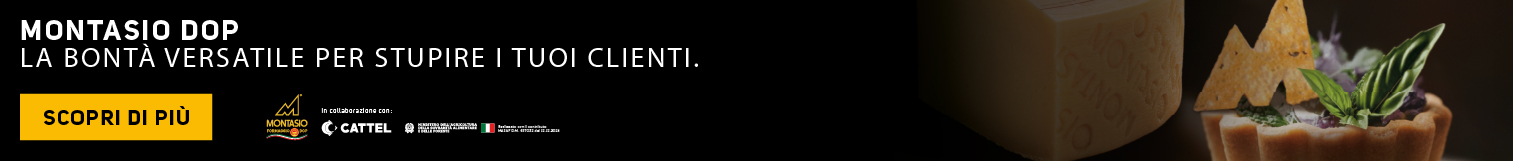La Storia
Ante litteram, ultra litteram. Lambrusco ma non solo. La mini rossa, come sempre, è parcheggiata in cima alla collina, davanti al simulacro di un agriturismo circondato dalle vigne. Simile piuttosto a un incompiuto colonizzato dalla natura, il cui intonaco è crepato dalla danza di lieviti e batteri. Tutt’intorno ferraglie e attrezzi agricoli, rudimentali innesti elettrici e perfino una seditoia abbandonata. Una cantina se non caotica, quanto meno spontanea che si sparpaglia fuori per qualche metro, in libertà come un laboratorio artigianale a cielo aperto.

Non si può fare una degustazione, premette Vittorio Graziano, in jeans e giacchetta attillata da rocker istrionico, se prima non si affonda il piede in vigna. Per capire il bene e il male di una terra fraintesa e spesso violata. Anche adesso che scrivere “Lambrusco” in etichetta va di moda. Da una parte piante basse e singolari, con il solco del sovescio fra i cordoni; subito oltreconfine viti allampanate e ben distanti, per esigenze di meccanizzazione, issate sopra trampoli per cui si perde la terra. Sui colli di Castelvetro, dove le rese si rimpiccioliscono come i campanili nella bassa, dove un ettaro può fruttare anche 300 quintali, il quintuplo di qui. Ma il problema è stato il business, prosegue Graziano. Il business del basso costo delle materie prime e del basso prezzo di vendita, che significa concimi chimici, antiparassitari, diserbanti e irrigazione, insomma il massacro della terra. C’è una bella differenza fra una pianta espansa per un metro e mezzo e un’altra che ne fa quattro: diventa un albero, produce di più, ma deve nutrire anche il fusto e la parte venosa.

Quando è partita la nouvelle vague dei vini naturali, però, Graziano era già un produttore di riferimento. “Faccio naturale da quando ho iniziato, nel 1982. Ma la pensavo così anche prima: che il vino dovesse essere genuino, prima ancora che naturale. L’industria da queste parti è arrivata alla fine degli anni ’60, ma per tanto tempo è sopravvissuta qualche enclave di autoproduzione, per il consumo familiare o il piccolo commercio in zona. Io poi ero astemio, proprio non ne volevo sapere. Ma c’era questa ragazza, la Paola, che era la più bella di Castelvetro. Li facevo impazzire tutti e per farla cedere, mi suggerirono di provare col vino… È stato così che nel 1969 è cominciato tutto quanto: per amore. Anche mio padre faceva vino, alla buona. Tanto che quando è mancato, nel ’74, ci ho provato e sulle prime è uscito un vino scurissimo, spesso, forse perché l’annata era stata molto calda e avevamo raccolto poca uva. Pensando che non fosse buono ce lo siamo dimenticato in cantina e dopo due o tre anni, quando me ne sono ritrovata una bottiglia fra le mani e ho provato a stapparla, era eccezionale”.


“Come ho imparato a fare vino? Sono autodidatta, ma al 90%. Perché ho letto qualche libro, che alla fine non è stato troppo utile, ho intervistato le persone qua e là, ho ascoltato i vecchi e anche qualche tecnico sano. Sono partito dalla semplicità contadina di quell’autoproduzione, che l’industria stava travolgendo. Perché un tempo c’erano altri impianti, la densità era molto più alta e le viti più fitte, quindi la qualità era diversa. Così quando è esplosa la voga del vino naturale, mi è sembrato qualcosa di ovvio. Perché già lo facevo, anche se eravamo in pochi a resistere all’attacco e alla cultura del vino industriale”.

Oggi Graziano produce su 4 appezzamenti e 5 ettari, compreso Château Telon, con il suo capanno che sbertuccia la teologia dei blasoni d’Oltralpe. Ed è un vino eroico a modo suo, fatto per saltar fuori da strettoie non meno ripide di una terrazza in Valtellina, crinali fatti di numeri altissimi e scoscesi che sembrerebbe impossibile scalare. “Il problema grosso è che tutto questo non interessa a nessuno: si dà per scontato che il mito quantitativo del vino più venduto al mondo sia vincente, mentre il business ha violato il rapporto con la terra e la natura, creando un grosso danno ambientale. Lo stesso prezzo di vendita in realtà è stracciato e le eccedenze si accumulano. Allora cui prodest?”.


Adesso però il Lambrusco è di moda e si stappa anche nei tre stelle. “Ma è un riscatto fasullo, perché non è stato rilanciato il Lambrusco autentico, ancora relativamente sconosciuto. Si tende a identificarlo col Sorbara, che può essere anche ottimo, e in generale con acidità eccessive. È un’idea limitata”.

Ma non è solo l’uva brusca a spalancare l’abisso orizzontale della poesia quotidiana. Graziano ha salvato la cultura locale delle uve bianche, che forniscono bottiglie dalla piacevolezza irresistibile, leggere nel senso filosofico della parola. Ripa di Sopravento, per cominciare, dal nome del suo cru, blend di una decina di vitigni, fra cui i locali trebbiano modenese e di Spagna, o trebbianina. Gli altri sono tuttora ignoti, raccolti qua e là per vecchie vigne al fine di massimizzare la biodiversità enologica. “Mi capitava di passeggiare e vedere una pianta che non conoscevo in periodo prevendemmiale; poi ho avuto qualche vigna vecchia in affitto e c’era sempre in mezzo una sorpresa. Così ho fatto i miei innesti”. È lo stesso uvaggio del Brutsprinstin, che però viene imbottigliato con un maggior residuo zuccherino e sviluppa più CO2. Mentre lo Smilzo, il rosato frizzante della casa, è prodotto con sorbara coltivato a Castelvetro, uva tosca e un terzo vitigno sconosciuto.


Poi c’è il Lambrusco da uva grasparossa, ovviamente, che qui esce quando è pronto. “Perché lo diceva già l’agronomo Francesco Aggazzotti nell’800, che il Lambrusco deve avere come minimo 2 o 3 anni, fino a 6, quando raggiunge il massimo della bevibilità. Ma può durare anche decenni. Vuol dire che a quei tempi non era un vino stupido. Mentre adesso a gennaio è già pronto e fra un po’ sarà sugli scaffali prima della vendemmia”. Si chiama Fontana dei Boschi, da un altro cru, e nel 2017 Ard (A Rifermentazione Disperata), perché l’annata secca ha concentrato i tannini e sguinzagliato un’inedita vena animale. “Ma non chiamatelo metodo ancestrale: piuttosto metodo emiliano. Perché l’ancestrale in Francia prevede l’imbottigliamento diretto in autunno a fine fermentazione, mentre da noi il vino matura per tutto l’inverno e viene imbottigliato a inizio primavera, in modo che si decanti da tartrati e fecce e risulti più fine. Con i primi freddi autunnali del resto la fermentazione si arresta e resta in canna la riserva zuccherina per ripartire”.

In cantina però c’è anche un vino “importante”: il Tarbianaaz, che non pochi intenditori giudicano superiore al Valentini. Non viene prodotto tutti gli anni, perché l’uva deve essere perfetta. E il metodo è puro terroir: Graziano è andato infatti a riscoprire l’antica tecnica di produzione del trebbiano murato, praticata dai contadini della zona. Quando il cappello delle vinacce si alzava e la fermentazione era ben avviata, il tino veniva rivestito con una calotta in malta di gesso, talvolta munita di sfiatatoio, e svinato dopo due mesi. Quindi una lunga macerazione, senza contatto con l’aria, ma diversa anche dalla carbonica, da cui risultava un vino possente, dalla gradazione elevata. “Qualcosa che è stato completamente dimenticato negli anni ’70 da una Doc fatta negli uffici e non in vigna. Ma il nostro trebbiano è un grande vitigno, anche se non se lo ricorda più nessuno”.
Fotografie di Francesco Zoppi