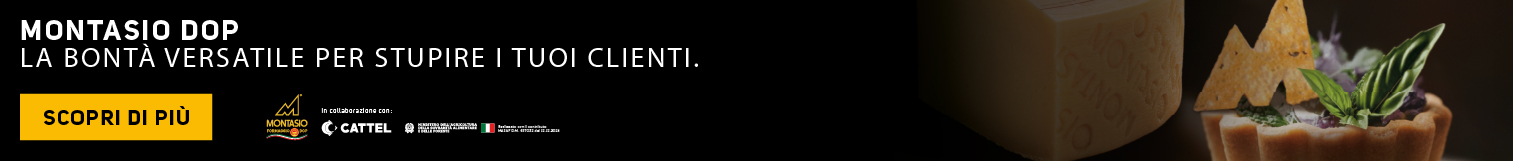Fino a che punto l’ospitalità può convivere con la pressione del profitto?
La notizia
Cinquanta minuti. Non uno di più. È il tempo che hai per goderti un drink sulla terrazza di un bar a Málaga. Poi, o ordini qualcos’altro, o ti alzi e te ne vai. È scritto nero su bianco su un cartello che ha fatto il giro della rete, scatenando più polemiche di un gol in fuorigioco. Non è uno scherzo, non è una performance artistica né l’incipit di un racconto distopico. È la regola affissa su uno dei tavoli di un bar andaluso, fotografata e rilanciata dal popolare profilo X (ex Twitter) @soycamarero, gestito da Jesús Soriano, cameriere e voce ironica — e spesso esasperata — di chi lavora nel settore dell’ospitalità. La foto del cartello ha fatto il giro della Spagna in poche ore, accendendo un dibattito che si è subito acceso di commenti, sarcasmi, insulti e riflessioni amare.

Per alcuni, è un tentativo disperato di tenere a galla un locale travolto dal turismo mordi e fuggi e dalla piaga dei “clienti da Wi-Fi”: quelli che si piazzano al tavolino con un espresso freddo e ci restano quattro ore. Per altri, è un’idea che sa di minaccia velata e rovina l’atmosfera di un luogo che dovrebbe essere sinonimo di piacere, lentezza e libertà. Ma cosa significa davvero quel timer invisibile che ora incombe su un innocente bicchiere di vino o su un cappuccino di metà pomeriggio? Bar e ristoranti, in fondo, sono da sempre i salotti non ufficiali del Mediterraneo. Luoghi dove il tempo si dilata, le conversazioni si srotolano, e nessuno ti corre dietro. O almeno, così è stato fino a ieri. Ma oggi — tra l’aumento dei costi di gestione, la difficoltà nel reperire personale, la corsa alla monetizzazione di ogni centimetro quadrato — anche una sedia al sole ha un prezzo. E il tempo non è più un dono, ma una tassa implicita. Cinquanta minuti: è questo il confine invisibile tra la tua libertà di restare e l’esigenza del locale di “fare girare i tavoli”. Passato quel limite, il sottotesto è chiaro: o ordini altro, oppure stai occupando inutilmente uno spazio che potrebbe essere più redditizio. “Se vedeste quel cartello, vi siedereste o ci passereste oltre?”, chiede Jesús Soriano sul suo profilo, rilanciando l’immagine ai suoi follower. La risposta? Un’esplosione di opinioni, battute, e giudizi più o meno taglienti.

“Passerei oltre, anche se dovessi fermarmi solo 30 minuti”, scrive un utente, “So che c’è gente che prende un caffè e ci sta tre ore, ma mettere un timer su un drink mi pare un po’ troppo”. C’è chi parla di deriva commerciale, chi invoca la sacralità del “tapeo” spagnolo, quel rito sociale che si consuma lentamente, senza fretta, tra bicchieri e tapas. Altri, più comprensivi, vedono la regola come un’arma necessaria per difendersi da chi abusa dell’ospitalità: “Lo capisco perfettamente”, scrive un altro commento, “troppa gente ordina poco e resta per ore a lavorare col Wi-Fi. E il personale si spezza la schiena per niente”. Il punto dolente, infatti, non è solo tra cliente e gestore, ma anche — e forse soprattutto — tra gestore e personale. Il settore dell’ospitalità in Spagna, come in molte altre parti d’Europa, è al centro di una crisi strutturale: salari bassi, turni infiniti, turn over altissimo e poco riconoscimento sociale. Eppure, ogni giorno, camerieri e cameriere devono fronteggiare una clientela sempre più esigente, a volte arrogante, e spesso poco incline al rispetto.

Il profilo Soy Camarero nasce proprio da qui: dal desiderio di dare voce a chi lavora con un vassoio in mano e troppo spesso è costretto a mordere la lingua. Jesús Soriano, il cameriere dietro l’account, raccoglie segnalazioni, aneddoti e immagini che raccontano — con sarcasmo e indignazione — la quotidianità nei bar e nei ristoranti spagnoli. Tra clienti che lasciano pannolini sporchi sul tavolo, ricevute con mance offensive, e ordini assurdi, la narrazione di Soy Camarero è spesso tragicomica, ma anche rivelatrice. E il famoso cartello dei “50 minuti per drink” è solo l’ultimo episodio di un teatro in cui i ruoli si confondono: chi serve e chi consuma, chi paga e chi subisce, chi giudica e chi sopporta. La domanda che resta sospesa è questa: fino a che punto l’ospitalità può convivere con la pressione del profitto? Quando un caffè si trasforma in un contratto a tempo, quando il bar non è più un luogo dove stare, ma solo un punto vendita con orologio, cosa perdiamo? Il cartello di Málaga, nella sua apparente banalità, fotografa un cambiamento profondo: la trasformazione dell’esperienza del bar in un’interazione a tempo, dove la socialità è subordinata al margine di guadagno. Non si tratta solo di fare cassa, ma di ridefinire le regole non scritte della convivialità. E il rischio è che, nel tentativo di proteggere l’equilibrio economico, si finisca per svuotare proprio ciò che rende un bar… un bar.