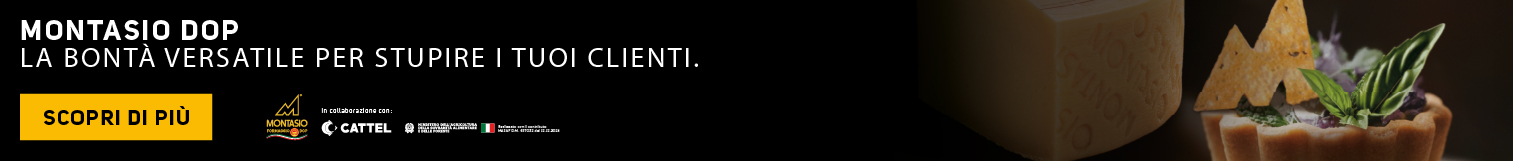Nel 2017, quando Ikoyi apre le sue porte, Chan sa che sta lanciando una sfida al sistema. Rifiuta i test “di laboratorio”, le prove su assaggi, le ricette ripetibili. Ogni piatto prende vita per la prima volta davanti al cliente. Ogni piatto è rischio. Vulnerabilità. Arte improvvisata e calibrata al millimetro.
Foto di copertina: Danny J. Peace
Ritratti nell'articolo: ©Maureen M. Evans
Lo chef
Non ha mai assaggiato una sola delle sue creazioni. Non per eccentricità, non per arroganza. Jeremy Chan cucina come si scrive un poema viscerale, ogni piatto che nasce dalle cucine di Ikoyi – il ristorante londinese che nel 2025 ha scalato le classifiche mondiali vincendo il premio Highest Climber nella lista dei World’s 50 Best Restaurants – è un frammento della sua autobiografia. E come si fa a mangiare un pezzo della propria anima? “Sarebbe come divorare me stesso,” dice in un'intervista al noto network internazionale.

Nato da una visione che rifiuta le etichette e abbraccia l’ignoto, Ikoyi non è un ristorante africano, né asiatico, né francese. È un territorio indipendente, privo di confini, dove le spezie sono lingua e memoria, e il sapore diventa archivio emotivo. È un luogo dove la cucina, più che espressione, è espulsione: la trasformazione dell’interiorità in materia commestibile. Secondo Chan, il gusto non è solo una questione di palato. È un’esperienza multidimensionale, stratificata, che intreccia la materia con il momento, l’aroma con la nostalgia, la consistenza con il contesto. Mangiare qualcosa in un vicolo di Hong Kong, in volo dopo un addio, o nel silenzio controllato di un ristorante stellato non è mai solo nutrimento: è un viaggio psichico e corporeo, un atto che assorbe e restituisce chi siamo.

“Il sapore è il risultato del nostro stato attuale, del nostro vissuto. Non possiamo ingabbiarlo in definizioni.” Questa consapevolezza guida Chan in ogni gesto culinario, e lo ha portato a rigettare qualsiasi “concept” preconfezionato. Ikoyi nasce in un vuoto fertile, pronto a lasciarsi invadere da qualsiasi dettaglio della vita: una zuppa di pepe nigeriana, un brodo cantonese, l’eleganza rarefatta di un tartufo bianco su una costoletta di vitello parigina. “Flavour is the output of my life’s journey,” afferma con risolutezza. Chi varca la soglia di Ikoyi entra in una sorta di rito alchemico. La spezia, in questa cucina, non è un elemento decorativo, ma la chiave d’accesso a un mondo emotivo bruciante e sacro. È dolore e piacere insieme, gioia e memoria condensate in un colpo di fuoco aromatico. “Volevo usare il piccante come catalizzatore creativo,” racconta Chan, “perché è attraverso il fuoco delle spezie che la mia immaginazione prende forma.” Nel 2017, quando Ikoyi apre le sue porte, Chan sa che sta lanciando una sfida al sistema. Rifiuta i test di laboratorio, le prove su assaggi, le ricette ripetibili. Ogni piatto prende vita per la prima volta davanti al cliente. Ogni piatto è rischio. Vulnerabilità. Arte improvvisata e calibrata al millimetro, come un’orchestra che suona in diretta senza spartito, ma con una coesione così profonda da sembrare telecomandata dal cuore.

Non è jazz, non è libertà cieca. È rigore estremo. È minimalismo affilato che comprime anni, ricordi, spezie e dolori in un solo boccone. Un fiore di zucchina immerso in una riduzione intensa. Una seppia sminuzzata a lento fuoco che esplode in bocca con l’urlo del mare. È una cucina che mira a sembrare creata da una macchina, ma vive della più umana delle fragilità: l’imprevedibilità. La dichiarazione più destabilizzante di Chan resta questa: non ha mai mangiato nel suo ristorante. Non ha mai infilato una forchetta in uno dei suoi piatti. Non vuole farlo. Non deve farlo. Perché la sua cucina non è destinata a lui, ma agli altri. “Il motivo per cui cucino è vedere la gioia negli occhi di chi mangia, non per provare ciò che ho creato.” Un’idea che sembra folle nell’epoca dell’ossessione per il controllo, ma che racchiude una visione profondamente spirituale. Per Chan, la cucina è come un gioco di calcio giocato senza trucchi, senza allargare le porte per segnare più facilmente. O come un’orchestra sinfonica che rifiuta la registrazione, e si affida solo al qui e ora, con tutta la fragilità e il potere del suono vero.

Ogni ingrediente che entra a Ikoyi ha una storia. Il manzo, ad esempio, cambia ogni giorno: dimensione, colore, venature, grana. “Non posso controllare come è vissuto l’animale, ma posso ascoltare ciò che mi dice,” spiega Chan. E così ogni bistecca viene trattata diversamente, osservata e letta come una poesia diversa. Il piatto nasce da questa relazione, da questo scambio silenzioso tra uomo e natura. La filosofia è chiara: non si può creare un cibo autentico se non si usano ingredienti che portano con sé la stessa integrità. Il prodotto è un’estensione del suo passato, e la cucina è l’eco amplificata di tutte le vite coinvolte. Dalle mani di chi coltiva, alle stagioni, al suolo. È una sinfonia di esistenze. Chan rigetta anche la moda della “purezza” a tutti i costi: l’ingrediente nudo, l’ostrica senza condimento, la fragola “perfetta” servita così com’è. “È una forma di esclusione,” dice, “un rifiuto del contaminarsi, del lasciar entrare altri sapori, altre coscienze.” Al contrario, la sua purezza è sincretica: nasce dal mescolare, dall’abbracciare tutto ciò che ha incontrato e amato. Un minimalismo che non semplifica, ma stratifica. Che in un solo boccone ti lascia l’eco di dieci luoghi, venti sensazioni, trent’anni di vita.

Il tempo, però, non è sempre complice. Più passa, più le voci esterne si insinuano. I clienti, le mode, i premi. “Quando abbiamo aperto, non mi importava del giudizio altrui. Ma ora ascolto troppo, e questo inquina la purezza delle idee,” confessa. È il rischio di ogni artista: cedere all’idea di piacere a tutti e perdere sé stessi. Ma Ikoyi resta una lanterna accesa in questa notte. Una cucina che nasce da dentro e si offre al mondo, anche a costo di non essere capita. Anche a costo di bruciare un po’. Perché il vero sapore non sta solo nella bocca, ma in quel punto segreto dove il ricordo si fonde con la pelle. E dove ogni piatto, se fatto bene, sa raccontarti qualcosa che non sapevi di sapere.