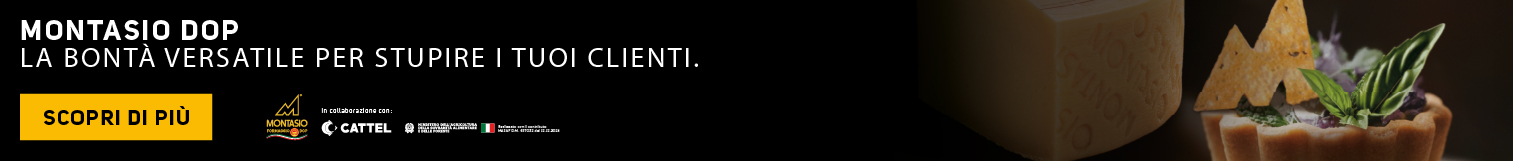Nato in una famiglia poverissima, pastore da bambino e poi ragazzino solitario a Madrid, Abraham Garcia ha fatto anche il cronista di ippica, prima del durevole successo ai fornelli di Viridiana. Da poco pensionato, ha scritto un libro di ricordi sulla guerriglia antifranchista. Ecco il suo racconto.
La storia
Sono appena tre mesi che Abraham Garcia, celebre chef settantatreenne, ha annunciato la chiusura del suo amato ristorante Viridiana a Madrid ed è andato in pensione. Una mossa che è giunta inattesa dopo sessant’anni di cucina, molti dei quali stellati (ricevette il primo macaron già nel 1983). Nato in una famiglia poverissima nel 1950, appendice di un dopoguerra interminabile, quando la madre filava la lana e rinunciava al companatico in favore dei figli, Abraham da bambino è stato pastore prima di frequentare per quattro anni la scuola e lasciare il suo paese, Robledillo sui monti di Toledo, a 13 anni in direzione Madrid, per cercare fortuna. La fama di cultura tuttavia l’ha sempre accompagnato, anche grazie ad artisti e scrittori habitué, ed è stata coronata da un libro dedicato alla guerriglia antifranchista, intitolato Falciare i cieli.

“Il mio paese si trova all’incrocio di montagne e cammini”, ha raccontato in una recente intervista a El Pais. “Oggi i guerriglieri si rifugerebbero nelle grandi città, ma allora si nascondevano in montagna. La repressione fu terribile e durò fino al 1960. Quasi tutti conoscevano qualcuno. La maggior parte di queste storie veniva raccontata di fronte al fuoco, a voce bassa, mentre il crepitio delle braci attutiva i rumori esterni. C’è stata molta paura per moltissimo tempo. Allora avevamo la lingua attraversata da uno stecchino, come le melanzane di Almagro. Due dei miei quattro nonni partirono in guerra, entrambi sul fronte repubblicano, e nessuno ne parlava, forse perché c’erano stati soprusi da tutte le fazioni. Una cosa grandissima è che non ci hanno trasmesso rancore”. Ma nella sua vita avventurosa c’è stato tempo anche per una carriera da cronista di ippica, tanto che ha sempre disdegnato la carne di cavallo.

“Ho cucinato dai 13 ai 73 anni. I fornelli non mi mancano, perché cucino per familiari e amici. Ma ho una piccola nostalgia, una specie di sindrome di Stoccolma per quello che era un luogo di socializzazione. Quando ho chiuso è stato un grande giorno, ho detto che avrei bevuto lo stagno del Retiro in Champagne e ho ancora motivi e bottiglie per festeggiare. Ma ci sono cose positive e negative. Talvolta volevi andartene e non potevi, perché la gente, in questi tempi di culto del cuoco, voleva vederti. Altre volte non saresti più partito. Immagina di avere Garcia Marquez a tavola, cosa che mi è successa varie volte”. Ora però ha finalmente tempo per andare al mercato, al cinema, a teatro e anche al ristorante, per quanto difficilmente ne esca soddisfatto. Della sua lunga carriera salva un paio di piatti: il gazpacho di fragole, nato dalla vecchia usanza di impiegare ciò che c’era, e le uova al tartufo.

“Che quando le ho fatte, ho pensato di vedere la Madonna”. Scherzosamente si definisce il nonno della fusion, grazie alle valigie stipate che ha portato indietro dai suoi viaggi. “L’immaginazione è memoria fermentata. A un certo livello la differenza fra buono, buonissimo e sublime è scarsa, ma decisiva. Personalmente non faccio la comunione con le ostie sferificate, sono sempre stato un detrattore di questo tipo di cucina e mi sono fatto dei nemici. Questo paese è il paradiso del prodotto, altro che piramidi di fumo”.