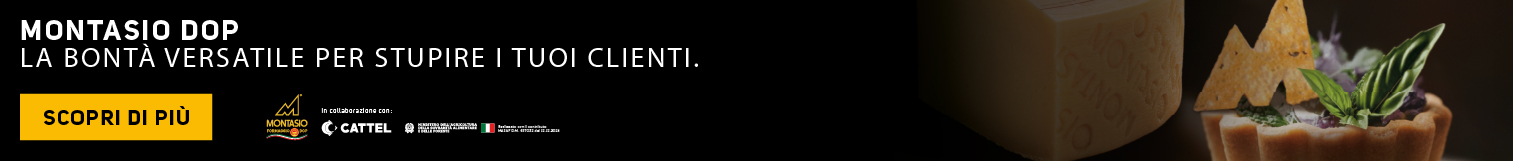Il grande critico inglese, voce storica di Decanter, ripercorre mezzo secolo di vino e racconta la sua filosofia: niente dittature del gusto, il vino va condiviso e ascoltato, non ridotto a una gara di punteggi.
Il vino non è mai solo nel calice. Porta con sé epoche, crisi economiche, riviste nate tra forbici e colla, dispute culturali e piccole ribellioni intellettuali. Così racconta Hugh Johnson, il più elegante e ironico cronista del mondo enologico, ricordando la nascita di Decanter nell’estate del 1975. A ovest di Londra, in un’epoca segnata dalla crisi petrolifera e da un’Inghilterra non proprio scintillante, prendeva forma un’idea nuova: un magazine per chi amava il vino senza pretendere di essere un esperto, colorato, accessibile, capace di intrattenere prima e illuminare poi.
Johnson, con il suo passo leggero e la memoria tagliente, ricostruisce un tempo in cui il vino era meno spettacolo e più mistero. Nella sua voce si sente il fruscio delle pagine incollate con Cow gum, il profumo di carta stampata che prometteva un modo diverso di raccontare bottiglie, annate, vigne e degustazioni. Decanter, che oggi celebra i cinquant’anni, nacque così: più che una rivista, un gesto culturale.
Chi è Hugh Johnson
Prima di diventare la penna più rispettata del vino, Hugh Johnson aveva già attraversato mondi editoriali complessi. Su Vogue mosse i primi passi, su Queen si ritrovò a sostituire un direttore leggendario come Jocelyn Stevens, mentre parallelamente coltivava l’altra sua grande passione: il giardinaggio. La Royal Horticultural Society gli affidò il compito di trasformare il proprio Journal, centenario e ingessato, in una pubblicazione vivace, leggibile, capace di parlare a un pubblico più vasto. Johnson, dunque, non è mai stato solo un critico di vino: è un tessitore di linguaggi, un ponte tra la serietà dell’esperto e la curiosità dell’appassionato.
Come è cambiato il mondo del vino
Negli anni Settanta, il vino era un territorio ancora pieno di ingenuità. Bordeaux regalava appena due annate memorabili, mentre la Germania sorprendeva con bottiglie luminose. Le tecniche erano più rudimentali, i vini spesso venivano considerati “buoni ma bisognosi di tempo”, perché acidi e tannini non venivano domati come oggi. Era un mondo meno saturo di informazioni e di capitali, più ingenuo e per questo più intimo.

Una delle immagini più vivide evocate da Johnson riguarda una degustazione quasi irreale: otto annate ottocentesche di Château d’Yquem, il re dei Sauternes, aperte nello stesso momento. Una festa per il palato, eppure ridotta a una gara: la 1847 fu eletta la migliore, mentre le altre, ciascuna capace di illuminare una serata intera, finirono quasi ignorate. E qui affiora la vena polemica del critico: il vino non dovrebbe mai diventare una competizione, ma un atto di condivisione. Non importa stabilire chi vince, conta scoprire le sfumature, celebrare ciò che ogni bottiglia racconta, anche nelle sue imperfezioni.
“Tra gli amanti del vino l’obiettivo dovrebbe essere semplicemente l’apprezzamento”, scrive Johnson, “condividere le qualità che ciascuno gode in un vino… persino sorvolando sui difetti.” È una filosofia che ancora oggi suona come una lezione di eleganza: assaporare invece di misurare, raccontare invece di classificare.
Numeri e classifiche
Ma il mondo del vino non è rimasto immobile. Con l’arrivo di Robert Parker e del suo sistema di punteggi in centesimi, anche Decanter si è trovato “costretto” ad adottare numeri e classifiche. Johnson non ha mai nascosto la sua insofferenza verso quella che definiva “la dittatura del gusto di Baltimora”. Il suo metodo personale era più istintivo, quasi teatrale: posizionare le bottiglie in fila e, a seconda della degustazione, spingerle avanti o indietro, disegnando un quadro immediato delle preferenze. In Germania, ricorda divertito, c’ era persino chi decretava il vincitore misurando con un metro quanta parte del vino fosse stata bevuta. L’etichetta più svuotata, vinceva. Un criterio discutibile, certo, ma irresistibilmente umano.
Questa tensione tra classificazione e libertà, tra il bisogno di dare un numero e il piacere di raccontare, resta il cuore del dibattito enologico moderno. Johnson, con la sua ironia, ci invita a non dimenticare il lato edonistico: “Cosa c’è di sbagliato nell’edonismo? Lunga vita a Decanter!”
Rileggendo oggi le parole di Hugh Johnson, si ha l’impressione che la sua visione resti attualissima. In un’epoca in cui il vino rischia di diventare status symbol, oggetto di speculazioni o di “collezionismo da caveau”, la sua voce ci ricorda che la vera grandezza di una bottiglia sta nel gesto semplice di alzarla insieme agli altri. Il vino non ha bisogno di trofei: basta che sappia raccontare una storia, che accenda la conversazione, che renda memorabile un incontro.

E forse è proprio questa la forza di Decanter, che in mezzo secolo non ha mai smesso di essere un laboratorio di racconto, uno spazio dove la competenza si mescola alla curiosità, dove i vini non si mettono in fila per una medaglia ma per un dialogo.
La lezione di Johnson, a distanza di cinquant’anni, è chiara come un calice limpido: più che giudicare, il vino va ascoltato. Non per stabilire chi primeggia, ma per scoprire ogni volta, con meraviglia, ciò che di unico porta con sé.