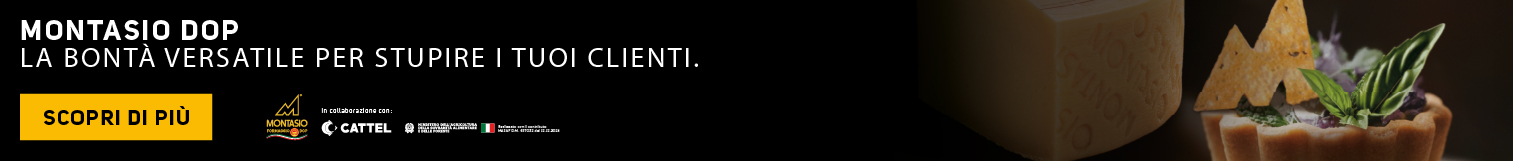Uno dei rarissimi posti al mondo dove una cena su misura è questione di fluidità, d’un incedere dei prodotti e delle tecniche, al servizio di sapori sempre diversi e inattesi nelle loro declinazioni. Le Clarence sta scrivendo la storia della cucina francese moderna e Christophe Pelé è un fuoriclasse che convince tutti (giovani inclusi).
Foto di copertina: Yohann Vorillon per Le Chef Magazine
E se facessimo un gioco di società? Chiediamo ad un cuoco di nostra conoscenza, francese di preferenza ma non obbligatoriamente, però della media e nuova generazione -razzoliamo largo: diciamo dai 25 ai 50 anni- chi rappresenta secondo lui l’eccezione, la personalità non ancora riconosciuta, a Parigi e altrove, all’altezza del suo immenso talento. Insomma, il cuoco che più ribatte le carte, quello che va per la sua strada, senza cavalcare le mode, le liste o i rankings internazionali. Né strombazzare su Instagram, un giorno sì e l’altro pure, le sue ultime fotogeniche trovate. E potremmo continuare a lungo col pitch.

Lo chef più unico che caro, che non salta mai un servizio, affatto abbonato ai voli intercontinentali, fedele in cucina ogni giorno che Iddio comanda, poco o mai visto a far lo scemo sul podio dei congressi, che ai messianici messaggi autopromozionali preferisce di gran lunga il certosino lavoro quotidiano sui fornelli. Dite la vostra che intanto noi spifferiamo la nostra. E, scommettiamo? Non saremo i soli a dare il nostro suffragio, affinché vinca il migliore, a Christophe Pelé.

Il ristorante
Lo trovate a Parigi al Clarence, appena dietro i Champs-Elysées. In un hôtel privato del 19° secolo, scrigno fuori dal tempo di proprietà del Principe Robert del Lussenburgo che nel 2015 l’ha ideato, contro ogni logica commerciale, per festeggiare gli 80 anni della proprietà famigliare Clarence Dillon - vi dice qualcosa lo Haut Brion?

Un’oasi d’eleganza, dove il contrasto tra il classicismo dei differenti ambienti -tre saloni da nobile castellani, biblioteche e certificate pitture d’epoca comprese- e le affilate creazioni di Christophe Pelé produce degli inusitati effetti di senso.


È la somma magia del Clarence, tavola sommum perché sintesi evolutiva di trenta anni di cucina francese ai massimi livelli. Trovatello Pelé non lo è: viene dalla scuola di Bruno Cirino, indimenticabile mentore che incarnò, col brio che storicamente si sa, sui fornelli del Carpaccio al Royal Monceau un certo spirito del dolce stil novo franco-italiano. Condividendo per anni col giovane braccio destro il disco duro del suo decennale sapere, il rispetto della stagionalità e dei migliori prodotti come conditio sine qua non. Pelé lo scoprimmo come tanti in epoca non sospetta sotto i riflettori della Bigarrade, tavola d’autore che nel 2007 cavalcò - o anticipò o accompagnò: scegliere l’opzione preferita- l’ondata della bistronomia parigina. Una botta di vita, di libertà, di azzeramento degli orpelli della gastronomia in quei tempi di transizione.

Per cucinare partendo dall’essenziale: dall’intuizione, l’improvvisazione controllata, l’esplorazione degli innati limiti dell’esercizio. Praticare un’altissima cucina a prezzi quasi per tutti con un’equipe ai fornelli ridotta al midollo: la missione – impossibile?- Christophe la stravinse e alla grande. Per anni risultò invero più facile introdurre un cammello per la cruna d’un ago che trovare un posto nel suo atelier del gusto. Particolarmente da quando la stessa Michelin s’inclinò, validando non con una ma con due stelle la singolarità del suo estro. Poi, dopo anni in apnea dura (“quando preso dall’urgenza fatichi a vedere chiaro oltre la linea di fondo del quotidiano”) fu questione d’ossigenarsi lasciando dietro di sé l’usuale (in)comfort zone. Fuori dal recinto della bistronomia franco-parigina. In Asia, nel lontano Oriente. O prendendo d’assalto l’assediata cittadella dell’alta gastronomia.

“Un giorno, facevo ancora la spola tra Parigi e Hong-Kong, erano i tempi in cui mi occupavo di “Serge et le phoque”, pop up permanente creato con Fred Peneau, il cofondatore dello Chateaubriand, venni per caso a conoscenza del progetto Clarence. Passati gli incontri preliminari, mi fu chiesto di organizzare una cena test per il Principe. Davo per scontato che non ce l’avrei fatta, non avevo il profilo del candidato ideale. Tanto più che tra i postulanti c’erano tutti, dico bene tutti - Ducasse, Alleno, Savoy- i più grandi di Francia e di Navarro. Alla fine -sorpresa generale e la mia in particolare! - quello che invece passò gli esami fui proprio io".

"Se ripenso agli esordi, alle prime carte del Clarence nell’autunno del 2015, mi rendo conto che nell’aria c’era una forma di soggezione, un timore dettato dal luogo talmente importante nella sua patrizia configurazione, che ci faceva privilegiare un certo classicismo, avvertito come naturale. Del quale dovemmo progressivamente liberarci. Trovando giorno dopo giorno le nostre marche. Oggi sono i nostri stessi clienti i primi ad offrirci una carta bianca senza condizioni".

"Abbiamo dei fans che vengono a mangiare da noi a mezzogiorno anche tre volte a settimana. Ovvio, il Clarence non è un ristorante da tutti i giorni. Ma non per questo siamo un posto solo per grandi occasioni, fuori dal tempo. Per me è importante iscriverci in un contesto per niente impermeabile al resto della società. Basta guardare l’età media del nostro pubblico, le giovani generazioni sono tra le più assidue” commenta Christophe Pelé con la sua gutturale parlantina che non poco ricorda, per le digressioni, le brusche pause e le circonvoluzioni discorsive, d’un Pierre Gagnaire, altro maestro di vita. Poi, tra voli pindarici e brusca realtà: “Veniamo a noi: quanta fame avete stasera? Un po’? Tantina? Molta. Assai assai?”.

I piatti
Noi, da lui, la fame è sempre tanta - ma di conoscenza in particolare. Per cercar di carpire, più ancora che di capire, qual’è il segreto del Clarence. Uno dei rarissimi posti al mondo dove una cena su misura, l’improvvisazione mai lasciata sulla soglia, è questione di fluidità, d’un incedere dei prodotti e delle tecniche, al servizio di sapori sempre diversi, inattesi nelle loro declinazioni. Alla predilezione per la verticalità delle sovrapposizioni, cifra stilistica del Pelé dei tempi della Bigarrade, oggi si dispiega semmai un impatto visivo più sfumato.

La sorpresa è nel dettaglio, nel nitore della purezza, dell’implicito. La singolarità sfavilla allora tra le righe, tra le pieghe della Tartare di seppioline dove la freschezza del peperoncino fa comunella col finger lime e col lardo di collocata fuso (che burrosa animalità!) insieme alle bricioline d’alghe nori e un roseo petalo di cosmo bipinnatus. O nel crudo di Triglia al “pangrattato’ di mandorle, umeboshi e foglioline di tagete. È la musicalità della fuga, dello staccato, l’impetuosa eleganza del tratto. Al plateale impatto dell’immediato, Pelé preferisce di gran lunga la sospensione della temporalità. I teorici della letteratura san parlare di “suspension of disbelief”, ovvero della sospensione del dubbio, dell’incredulità. Christophe Pelé riesce come pochi a confutare l’improbabile.

Procedendo, scansione su scansione -là dove un tempo avrebbe optato per una costellazione di piatti satellitari- con un secondo e poi un terzo servizio di triglia. Dapprima col suo fegato presentato in un liquido unguento di kaki e mandarini per temperarne l’irruente amaro, poi last but not least, il filetto, spicy al punto giusto e affumicato, in un abbraccio conserto col midollo allo scalogno e la soia dall’incredibile, setoso efetto. A seguire senza transizione, ecco la mimesis d’una tradizione presa alla larga: il magnifico Rombo, dall’omeopatica cottura iniziale passato in seguito alla salamandra prima d’essere servito intero al tavolo con del cervellino di vitellino scagliato di tartufo bianco.

“Sarà colpa vostra se stasera il servizio va in pallone” dice en passant, sorridendo ma non più di tanto, il Maître d’Hotel. “In cucina, lo chef si sta innervosendo grave. Ha già cambiato due volte il menu, invertendo i prodotti, l’ordine dei piatti. Ci si è messo pure Andrea Capasso, il suo secondo, l’avevate incontrato al Lido 84 di Riccardo Camanini. Visto che non siete refrattari alle frattaglie, vorrebbe presentarvi la sua versione della coratella romana”. Tanto per scardinare ancor di più il già ben poco rigido pentagramma della serata. E come potrebbe essere altrimenti in una cucina che, per niente torre d’avorio, alla verticalità gerarchica preferisce di fatto l’empatia dei vasi comunicanti.


“La cucina del Clarence è la risultante di tutti quelli che la fanno. Siamo una quindicina, di varie nazionalità, con ben cinque italiani, tanti latinoamericani, altrettanti statunitensi e svariati asiatici. Giusto qualche francese, una minorità. Sia ben chiaro, non è una scelta deliberata. Risulta difficile anche per noi trovare dei collaboratori motivati, pronti a dare il massimo. Credetemi, la maggior parte delle candidature ci arrivano dall’estero. È il segno d’una crisi profonda delle vocazioni? Non saprei dire. In ogni caso si fa sempre più fatica a reclutare dei profili interessanti in una ‘grande maison’ dove la parola d’ordine é una cucina davvero cucinata, la mise en place ridotta al minimo possibile. Una cucina con tutte le fragranze dell’istante - benvenuta sia la presa di rischio- fatta minute. I menu già codificati a monte e mezzi belli già pronti quando si aprono le porte del ristorante mi annoiano da morire. Sono una vera contraddizione con i valori veri del nostro mestiere”.

Al Clarence nessun rischio di ritrovarsi alla mercé di mercenari o di ligi di burocrati del pensiero. L’agilità dei sapori va di pari passo con la dovizia dei contrasti. I prodotti di lusso san coabitare con quelli più ordinari, il vegetale si trasfigura nell’animale. Da Pelé, la metonimia sta di casa. Dove trovare altrove più folgorante idea del fegato grasso (“so so eighties”) messo al bando anche per la preparazione della Lièvre à la Royale, monolitico emblema nazionale?


La lepre secondo il mood board attuale, è snella, cinta nel suo feuilleté, la freschezza all’unisono della gelée con la burrosa farcia d’animelle, un capolavoro di serafica leggerezza. Stesso andante per il sequitur lepresco: brasato e con una salsa legata al sangue, si sposa a dei cavolini di Bruxelles che dire divinamente croccanti é litote di circostanza. Senza dimenticare il side dish per un ultimo prospettico ribaltamento: un polpo fritto nel suo kimchi di cavolo. Un’idea senza Dio né padroni, diabolicamente divina.

Attenzione, marzo é alle porte, si aprono le scommesse. Una terza stella Michelin al Clarence ricompenserebbe il talento d’uno chef fuori norma. Un magnifico cinquantenne, l’unico in Francia a poter fare da passerella tra le generazioni. Per riannodare il dialogo tra nobiltà, creatività e street culture: e chi se li scorda i suoi uccellacci e uccellini alla fried chicken cinese da mangiar interi, compresi gli ossicini? A Michelin ora l’ardua sentenza. Sarebbe di certo un segnale forte. Per la Francia ma non solo.

Contatti
Le Clarence
31 avenue Franklin-D.-Roosevelt, Parigi, 75008, Francia
Tel: +33 1 82 82 10 10