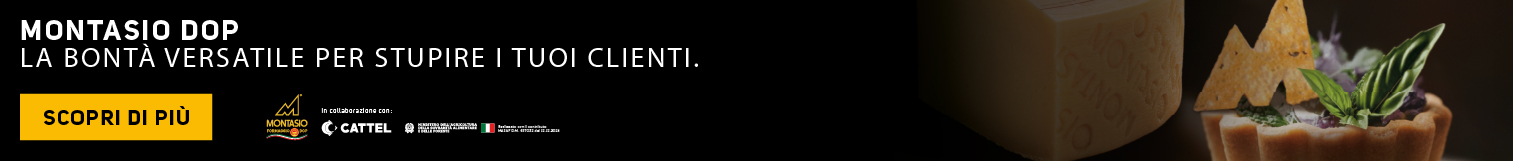Il suo ristorante Oteque a Rio de Janeiro, è riuscito in poco più di un anno a scalare le classifiche di tutto il mondo. Ecco la sua storia.
L'Intervista
Andrea Petrini lo considera uno degli chef più interessanti della scena mondiale. Brasiliano, con origini sia tedesche che giapponesi e una nonna italiana, Alberto Landgraf vive a Rio de Janeiro dove nel 2018 ha aperto Oteque, il ristorante che in poco più di un anno è riuscito a scalare le classifiche di tutto il mondo. Dopo l’esperienza di Epice a San Paolo, con cui si è guadagnato la prima ribalta internazionale, oggi vive con Oteque una nuova e importante fase professionale. Sposato con Nathalie Passos, chef del Nauralie Bistro dedicato a una cucina vegetariana, Landgraf è stato definito l’astro nascente della cucina sud americana dalla rivista Four e caratterizza la sua cucina concentrandosi su quella eredità giapponese basata non sugli ingredienti, quanto sulla semplicità, la tecnica precisa e un’alta etica.
Alberto, si sente più brasiliano o giapponese?
Mi sento assolutamente brasiliano anche se il mio paese è veramente un mix di culture diverse. Ho convissuto a lungo con questo dubbio nella mia mente anche perché, da un punto di vista culinario, le culture gastronomiche dei miei genitori non hanno mai influito sulla mia professione. Io ho imparato a cucinare in Inghilterra quando sono arrivato nel 2000 per motivi di studio ed è stato un processo del tutto casuale. All’epoca il mio idolo era Albert Einstein e al college frequentavo corsi di fisica: ho iniziato a lavorare in un pub per pagarmi gli studi e dopo pochi giorni in cucina ho capito che quello sarebbe diventato il mio lavoro.

Da cosa l’ha capito?
Io sono una persona molto precisa e, approcciando il lavoro di cuoco, ho realizzato che la cucina è l’unica disciplina in cui non solo coinvolgi tutti i sensi, ma è il giusto mix di chimica e matematica, devi conoscere la storia, la cultura, devi saperti rapportare con le persone: è un lavoro profondo che mette insieme un’infinità di scienze e insegnamenti differenti. È ben più complesso del mettere un pesce in una pentola: devi capire chi lavora con te e che magari arriva da nazioni e continenti differenti con diversi usi e modi di pensare. Lavorare come cuoco è una professione completa e l’ho scelta per questo, oltre che per l’amore che nutro per il mangiare e per il cucinare, ovviamente.

Qual è stato dunque il suo percorso professionale?
Ho iniziato in un classico pub londinese in cui la cucina era basata prevalentemente sull’utilizzo del microonde, quindi a livello tecnico non ho imparato quasi nulla, ma quel poco che ho visto ed appreso mi è servito ad avvicinarmi a questo mondo. Il mio titolare dell’epoca è stata una figura molto importante per la mia professione: ha visto in me delle capacità e mi ha aiutato a evolvere le mie conoscenze trovandomi un lavoro in un hotel di Londra. Non si trattava di una cucina Michelin, ma era una cucina giusta per iniziare a imparare e lì sono rimasto un anno. Al mio datore di lavoro del pub devo molto: oltre ad avermi indirizzato verso la professione, mi ha dato consigli importanti come quello di fare esperienze annuali in posti diversi per cinque anni (mi disse) per poi raccogliere ciò che avevo imparato e iniziare a creare il mio modo di cucinare. Per questo gli sono ancora oggi molto grato.

Durante un suo intervento a Food on The Edge ha parlato anche dei ritmi di lavoro in cucina: pensa che il sistema debba cambiare?
Ho riflettuto molto su quando esposto da Ryan King durante il suo speach, nello specifico sul caso del giovane chef londinese Nathan Laity, che alcuni anni fa morì di tonsillite dopo 27 giorni di lavoro senza interruzioni. L’ho fatto anche io quando avevo 22 anni e, a Londra all’interno del primo hotel in cui ho lavorato, volevo dare il massimo e decisi di sostituire un collega per diversi giorni accollandomi il suo lavoro oltre al mio. È stata dura, lavori senza sosta con ritmi alienanti ed è inevitabile che la salute ne risenta. Oggi, non lo farei più e non permetterei a nessuno del mio staff di farlo. Le regole del lavoro in cucina oggi devono cambiare perché è il mondo stesso che si evolve e noi dobbiamo farlo di conseguenza: anche i più ferrei dettami di questo ambiente o si modificano o rischiano di diventare anacronistici. Per questo nel mio ristorante ho impostato in modo completamente diverso il nostro approccio al sistema: personalmente do la stessa importanza a tutte le persone che lavorano con me e se organizziamo delle uscite comuni tutti sono invitati a partecipare. Lavorare in una cucina può essere molto stressante, ma io faccio di tutto affinché non lo sia. In Brasile per legge si lavora sei giorni e si ha diritto a un giorno di riposo: noi lavoriamo solo cinque giorni ed esclusivamente la sera. Siamo sicuramente un ristorante privilegiato, ma poiché nella vita ho avuto tanti privilegi, cerco di restituire quello che mi è stato donato tentando di fare il meglio che posso per chi lavora con me.

Pensava di riscuotere il grande successo che sta ottenendo in così poco tempo?
Quando da San Paolo decisi di spostare il mio ristorante a Rio de Janeiro pensavo di aprire un posto semplice in cui poter cucinare tranquillamente, ma poi il progetto è diventato così grande e ci sono state così tante aspettative nei miei confronti che mi sono ritrovato prigioniero di ciò che avevo creato nel passato. Oggi invece mi sento libero di realizzare una cucina fine dining con il meglio che ho a disposizione: il miglior ristorante, le migliori materie prime, i migliori vini. Quando ho deciso di lavorare ai massimi livelli mi sono sentito finalmente libero e oggi posso dire di essere anche molto soddisfatto perché in un anno e mezzo abbiamo ottenuto una stella Michelin, siamo tra i migliori ristoranti del Sud America per i 50 Best Restaurant e rientriamo nel loro rank mondiale tra i migliori 100. Sempre quest’anno in Brasile abbiamo vinto 11 premi, il ristorante è sempre pieno e ho raggiunto quello che volevo: un luogo vivo, con gente giovane e affiatata, un ristorante vivace e ricco di energia positiva, di belle vibrazioni.


Come descriverebbe la sua cucina?
Quando sono stato in Giappone ho acquistato un libro che si chiama White e che è stato scritto dal proprietario di Muji. Alla fine del volume l’autore racconta che quando ha creato Muji il suo goal è stato quello di far diventare il semplice complesso e di rendere il complesso semplice. Ecco questo concetto è ciò che descrive meglio il mio cibo. Ogni mio piatto, poi, deve seguire la regola dei tre elementi: deve avere texture, acidità ed essere servito alla temperatura corretta, quindi non troppo caldo né troppo freddo per non inibire i sapori. Come fare? Beh per trovare la temperatura giusta la puoi solo provare, assaggiare e anche ovviamente sbagliare. Bisogna assaggiare in continuazione per fare questo lavoro: me lo ha insegnato all’inizio della mia carriera sempre il proprietario del pub di cui parlavo prima. Se vuoi essere un grande chef, mi disse, devi mangiare: la differenza tra un bravo cuoco e un grande cuoco è il palato. Un bravo chef può eseguire, ma solo un grande chef può assaggiare.

Dopo le esperienze nell’hotel londinese e prima di aprire il suo ristorante a San Paolo, dove ha lavorato?
Ho fatto esperienze a Londra da Tom Aikens e Gordon Ramsay, ma anche al Noma, a Parigi da Pierre Gagnaire all’Hotel Balzac e poi sono rientrato in Brasile per un problema di salute di mio padre. In quel momento ho capito che avrei dovuto decidere se restare nella mia terra o tornare in Europa: ho scelto la prima ipotesi e ho deciso di prendere parte al grande movimento di rinascita culinaria brasiliana. Dopo il mio ritorno ho però dovuto aspettare cinque anni prima di aprire il mio ristorante a San Paolo: mi mancava il denaro e non sapevo nulla del mercato sud americano, era tutto diverso dal mondo europeo e ho dovuto capire il sistema a cui mi stavo affacciando. Per questo ho lavorato a lungo per diversi hotel anche come project manager: mi occupavo di aprire nuovi ristoranti del gruppo scegliendo le location, lavorando con architetti e fornitori, selezionando staff e materie prime. Ho imparato tantissimo ed è stato fondamentale per calibrare la mia apertura.

Quale pensa sia il suo prossimo goal?
Beh è ovvio che se hai una stella Michelin ne vorresti due, se sei centesimo nella lista dei 50 Best Restaurant vorresti arrivare almeno ottantesimo, la voglia di accrescere i risultati professionali è tanta. Se mi avesse fatto questa domanda cinque anni fa avrei parlato esclusivamente di cucina, ma oggi è diverso. Oltre a rendere funzionale e sostenibile il mio business, ovviamente, il mio grande goal è quello di stare in famiglia con mia moglie, avere un figlio, dedicarmi ai miei affetti. Ho altri obiettivi rispetto al passato: lo scorso anno, dopo tanto tempo, mi sono finalmente deciso a prendere un cane (che adoro) e quello che veramente voglio è che anche sul lavoro la gente stia bene, impari, sia felice e viva meglio.

Come lavora con la sua brigata?
Da quando ho aperto Oteque collaboriamo moltissimo, prima invece non accadeva. Mi sento uno chef migliore e con più esperienza rispetto al passato e nel momento in cui mi sono sentito libero (anche dalle opinioni) mi capita di portare avanti idee non mie se vedo che i clienti sono contenti. Ci sono tre ragazzi che mi seguono dall’inizio e con loro si è instaurato un bellissimo rapporto. Mi aiutano molto nella creazione dei piatti, hanno accumulato esperienza e uno di loro è stato a lavorare da Amass a Copenhagen e al Blue Hill di New York, mentre un altro è andato al Le Bernardin: sono tornati con molta più conoscenza e consapevolezza di questo lavoro e questo aiuta il processo creativo. Lavoriamo tanto anche sul wine pairing con i nostri sommelier non dando loro un piatto già finito a cui dover trovare il giusto abbinamento, ma assaggiando insieme e discutendo delle preparazioni con loro.

Andrea Petrini parla di lei come della nuova rivelazione del mondo della cucina. È contento?
Andrea Petrini è una persona che stimo molto e credo di piacergli anche perché non sono uno chef che parla solo di cibo. Abbiamo tanti interessi in comune e insieme discutiamo di arte, musica, letteratura, architettura. Le arti in generale, secondo me, sono molto legate al mondo della cucina perché mettono in relazione le persone e le loro emozioni e sono soggettive. La passione comune per la letteratura ha poi spinto Andrea Petrini a invitarmi a partecipare all’European Food Summit che si terrà a Lubiana, in Slovenia, dal 27 al 30 marzo 2020. Qui Petrini vuole che faccia un intervento partendo dal libro Contro l’Interpretazione di Susan Sontag: nessun discorso da chef e quindi ho iniziato a leggerlo.

Il suo libro preferito?
Attualmente sto leggendo la biografia di Leonardo Da Vinci scritta da Walter Isaacson e la trovo entusiasmante. Al di là delle sue doti artistiche, Leonardo era un personaggio davvero interessante che ha addirittura inventato i tovaglioli per i ristoranti: ci sono talmente tante informazioni da metabolizzare in questo libro che lo leggo poco alla volta perché è davvero immenso.
Le è piaciuta l’edizione 2019 di Food on The Edge?
Tantissimo, non esistono altri congressi in cui c’è così tanta integrazione tra le persone. Spesso si parla ma non c’è interazione, mentre l’evento di Galway è realmente un’opportunità per creare legami. Gli speakers poi erano hanno tenuto discorsi veramente interessanti e ne ho tratto molte ispirazioni. Mi sento un privilegiato per la vita che ho fatto anche in confronto ad alcuni di loro che, in altre parti del mondo rispetto alla mia, sono messi in discussione per la loro nazionalità o incontrano problemi per svolgere la loro professione. Quando ero al Noma non ero che uno stagista e, all’epoca, in cucina lavorava anche Matt Orlando: quest’anno ero sul palco con lui a Food on The Edge e mi sono sentito come un bambino che gioca con il suo idolo calcistico, è stato veramente bello e incredibile.

Terminato l’evento irlandese, Alberto Landgraf è arrivato per la prima volta in Italia, dove è stato tra i protagonisti della XXI edizione di Ein Prosit che a fine ottobre ha radunato a Udine i più importanti chef mondiali. In sei giorni la manifestazione ha ospitato oltre 100 eventi, tra cui una serie di cene esclusive a cui ha partecipato anche lo chef brasiliano. La prima con Manu Buffara del Ristorante Manu di Curitiba, la seconda con altri due chef giapponesi: Zaiyu Hasegawa del Den di Tokyo e Yoji Tokuyoshi dell’omonimo ristorante milanese. “L’evento con Manu Buffara è stato dedicato alla cucina brasiliana e per questo ho portato in Italia diversi prodotti della nostra cultura gastronomica come il Tucupi che è una salsa estratta dalla radice di manioca selvatica. La cena con i miei colleghi giapponesi è stata invece un vero scambio di culture e di condivisioni: è stata la prima volta, per me, in cui ho ideato un menù contemporaneamente insieme ad altri due chef giapponesi. Ho cucinato in passato in Giappone da Zaiyu e ho invitato Tokuyoshi, di cui sono un grande fan, per una serata da me in Brasile, ma questa esperienza legata a tre visioni orientali di persone che vivono in angoli così diversi del mondo è stata davvero unica”.
Indirizzo
Ristorante OtequeConde de irajá 581 - Rio de janeiro – Brasil
Tel +55 21 3486 5758
Mail info@oteque.com
Il sito web