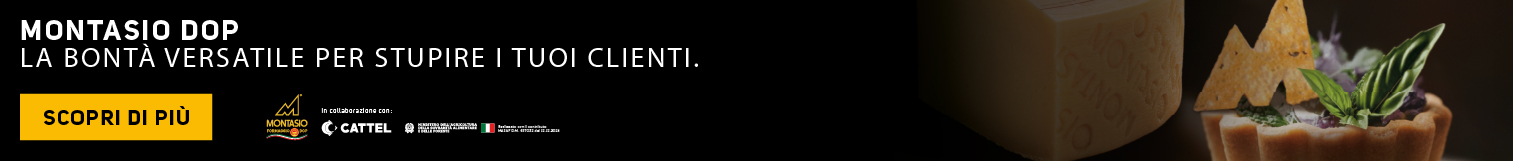Una ricerca dell’assoluto e dell’essenziale con l’evoluzione che sta nel delegare al vegetale il ruolo di attore principale e relegare a comparsa le proteine. Ecco la cucina di uno dei più interessanti giovani italiani.
La Storia
Fra i giovani chef italiani da tenere d’occhio c’è sicuramente Christian Mandura, trentenne di origini croate cresciuto a Torino. Fattosi notare per lampi di genio e sregolatezza in un’edizione di Emergente, dove conquistò la critica con un rigatone-gin tonic, divenuto poi improvvisamente “trendy” in un locale non meno irragionevole, eccolo da un anno abbondante alla sua prima, vera prova di chef. La quale non lesina sorprese.
Christian è un figlio d’arte: la mamma Annamaria, autodidatta totale, fin dalla sua infanzia cucinava in casa in un “home restaurant” ante litteram, dove i fratelli erano chiamati a sistemare la sala o fare la spesa, prima di assistere allo show; poi in un circolo a Torino. Fra i cavalli di battaglia la pasta e fagioli, le lasagne, la parmigiana, la trippa in umido con le patate e un ragù che conquistò perfino Bob Noto. “Qualcosa a livello inconscio deve essermi rimasto. Tanto che ho finito per iscrivermi all’alberghiero, seppure in sala. E ho cambiato indirizzo solo a causa del conflitto con un professore”.
La scintilla scocca alla Taverna di Frà Fiusch di Moncalieri, trattoria proiettata verso l’alta cucina dove ogni lunedì la brigata parte per qualche dining experience. “Luoghi dove prendevamo ispirazione, per esempio il pinzimonio di Alain Ducasse era diventata la nostra piccola bagnacauda. Ricordo che entrando in cucina un giorno vidi un impasto fosforescente e chiesi se fossero carote. ‘No, è la pasta di tuorli di Cracco’. E sono letteralmente impazzito”.

Da lì una serie di stop and go, sbandate, tregue e poi ritorni di fiamma, come in un amorazzo da rotocalco. “È stato Davide Scabin un giorno a consigliarmi di non mettere mai piede in cucina, qualora non ne avessi voglia, ma di prendermi piuttosto una pausa”. Dopo aver girovagato per qualche cucina torinese, compresa quella del Birichin di Nicola Batavia, eccolo a Ibiza per due estati di fila a smerciare prevendite da discoteca e ragionare pensoso sulla spiaggia. “Quando poi ho messo piede a Londra, ho subito capito che non era per me e ho sentito che dovevo fare bene, in quel momento e in Italia”. Al Sale di San Vincenzo incontra lo chef Timothy Magee, in arrivo dal Noma, dove poi lo manda in stage: la sua è una cucina del mercato contemporanea, che nasce all’asta di Piombino e fra le zolle dell’azienda agricola bio. Segue un altro stage decisivo al Cambio di Matteo Baronetto.

“Poi è successo che mia mamma, dopo aver chiuso il circolo, nel 2015 aveva trovato un nuovo posto, il Geranio di Chieri, ma aveva solo una base di cucina popolare per il pranzo; quindi ho pensato di impostarle un discorso serale di piatti fatti bene, ma semplici. Non pensavo di fermarmi, invece abbiamo fatto un bel lavoro. Certo se ripenso ad alcune cose, vedo una cucina meno matura, estrema, spigolosa, fatta per stupire”. Non lascia indifferenti, tuttavia: nonostante i limiti di uno schema di assemblaggio e di una certa imprecisione esecutiva, dovuta alla mancanza di mezzi, il talento è evidente e la mangiata diverte. Al punto che un habitué, Flavia Vallarin, per scherzo gli suggerisce di aprire un ristorante a Torino. “Solo se c’è un bancone da 10, o meglio 6 persone”, è la risposta scherzosa. Invece in pochi mesi è affare fatto: Unforgettagle apre nell’aprile del 2019 fra i mattoni vivi di uno spazio underground, praticamente uno speakeasy senza finestre se non sul piatto.

Tanto il Geranio era anarchico e irresistibilmente confusionario, quanto qui il concetto è tiranno, la tecnica esatta, la riflessività senza scampo. Il vegetale era già protagonista a Chieri, ma ora la rivoluzione è completa: è lui a occupare il centro di un piatto, con la proteina che gli ronza intorno come un satellite. Significa che la creatività e l’elaborazione, anche estrema, mirano a rendere praticamente autosufficienti un cavolo o un finocchio, mentre pesci e carni, in quantità trascurabili e perfino omissibili, apportano freschezza e acquosità allo stato crudo o minimamente civilizzato, variando il morso come di solito fa un contorno con la sua pietanza. E contrario.

Significa anche circolarità, nel senso del riutilizzo degli “scarti”. Lo sforzo è quello di non aggiungere neppure un grammo di sale, “confondendo” il palato con sensazioni piccanti o amare estratte dal vegetale stesso. Ma il profilo organolettico è più comfort che frastagliato, senza eccessivi picchi acidi o amari. Quella di Mandura è una ricerca dell’assoluto nel solco di Romito (unico argine alle nippofermentazioni dilaganti), animata dalla medesima ossessione domestica. “Perché è più facile stupire con piatti ex nihilo, che con qualcosa di familiare, dove ciascuno possiede un metro di giudizio, che sia la nonna, la mamma o la trattoria sotto casa. Cerco la massima comprensibilità, perché le fermentazioni ad esempio non fanno parte della nostra storia”. Ma la tradizione non va intesa in senso puramente piemontese: si allarga a tutte le regioni d’Italia e può varcare talvolta anche i confini, senza violare il caposaldo della familiarità. Peraltro gli insegnamenti di Baronetto non vanno perduti: brillano anzi nella padronanza della similitudine e nell’arduo schema binario, come il cavallo pazzo di una biga destinata a scossoni certi.

C’è il bancone unico, che in epoca covid indossa all’occorrenza i divisori, e ci sono un paio di salottini per l’aperitivo e il dopocena, visto che gli arrivi sono liberi e il turno può essere doppio, ma viene gestito con grazia. Il menu è unico, con la possibilità di omettere il contorno proteico e approntare variazioni per bambini o allergici: costa 70 euro, più 35 per il pairing italiano e 45 per quello francese. In cantina 150 etichette, fra cui risalta lo Champagne, senza esclusivismi in chiave bio. Con Christian un manipolo di cuochi, fra cui i fedelissimi Stefano Mancinelli e Daniele Mutti, che finiscono a vista le preparazioni, sgrossate dalla cucina sul retro, e servono i piatti. Per le loro mani passano gli ortaggi dell’azienda agricola Frutti Rossi, il pesce di Mauro Pallottino, le carni di una macelleria cittadina.
I Piatti
Si inizia con le rifrazioni di una conserva di pomodori frullati, scolati nella carta da cucina, non cotti ma abbattuti e nuovamente filtrati: un bloodymary in sineddoche, che preannuncia la domesticità del pasto. Poi i primi appetizer: il capunet reso croccante con le foglie vetrificate, il ripieno di foglie sbruciacchiate, senape e olio al rafano; il cilindro di spaghetti di patata passati nella friggitrice ad aria, per una testura quasi di sfogliatella riccia, con crema di patate alla panna e coriandolo, pomata di limone e limone salato; i deliziosi popcorn di capperi fritti.


Al banco si parte dalla degustazione di frutta: la prugna cozza, esercizio di similitudine e contrasto; il lampone con il suo carpione all’aceto di lamponi, per ripulire; la pesca scottata con acciughe sott’olio, omaggio a Baronetto. L’unico pane in tavola (con l’eccezione di un piatto) sono i grissini sopraffini del panificio Guala.

Gli antipasti salgono via via di temperatura. C’è innanzitutto il romitiano peperone (rosso) arrosto, monografia di un ingrediente passato ai raggi x: carbonizzato all’esterno, poi messo sottovuoto con il suo centrifugato, per ammorbidire e concentrare, viene affumicato 2 ore con legno di ciliegio e servito a filetti con una melassa di centrifugato di peperoni affumicati e un doppio contorno, di salsiccia di Bra, paradossalmente rinfrescante, per il classico abbinamento e pane al lievito madre di Raffaele D’Errico.

Poi la zucchina, sul modello della classica trifolata: viene sbucciata, essiccata, forata e cotta nel burro per 25 minuti, fino alla massima scioglievolezza, spolverizzata infine di polvere della sua buccia e di prezzemolo, per un ittico esplosivo. Viene ripreso dal contorno di gamberi rosa crudi di Santa Margherita, per la similitudine delle testure.

Infine il cavolfiore “gratinato”, dove l’ortaggio è lavorato alla francese nella panna, bruciato per sviluppare un amaro, che sopperisca alla mancanza di sale, frullato e sifonato per alleggerire. La crosticina è ricostruita dalla cialda di liquirizia, più una foglia cruda. Accanto, simile anche visivamente, una capasanta piastrata, in liaison iodata con la spezia.

Che Mandura, nonostante il romitismo, sia un creativo, lo dimostra la costruzione del tajarin ai porcini. “Perché mettere il vegetale al centro di un primo, dove solitamente è ridotto a condimento, è una sfida”. La vince essiccando i porcini: una parte va in polvere sul piatto, da cui sprigiona intense sensazioni di sottobosco; l’altra nella Greenstar, per un estratto che svolge la terrosità al palato, più un giro di olio al prezzemolo. Anche qui le parti sono invertite: sul piattino finiscono i sacri tajarin, appena conditi con olio di nocciole e sale, a temperatura fredda per la convivialità, il gesto primordiale italiano e soprattutto l’omaggio a Marchesi. Perché è a pizzicotti che vanno passati sul piatto, come una scarpetta.

Il secondo è l’unico piatto privo di contorno: si tratta della riedizione delle amalfitane melanzane al cioccolato. Vengono cotte in forno con la buccia, forate e fatte scolare sotto un peso; il liquido che se ne ricava viene trattato come un fondo di vitello e fatto ridurre con odori, mentre la polpa ripassata e frullata descrive tutt’intorno un anello, più una grattata di cioccolato brasiliano acidulo. L’esito (da leccare sul piatto o sulle dita) sorprende non tanto per il piccante, quando per un’astringenza prossima al tabacco, che accompagna verso il fine pasto. Perché non è solo la nippofermentazione a metaforizzare l’ingrediente: una questione di concentrazione volumetrica e mentale, sublimazione alcolica non meno che quintessenziale.


Anche il dessert ha un’impronta vegetale: si tratta della panna cotta con infusione di camomilla, il suo gel, i fiori essiccati e sciroppati.
Indirizzo
UnforgettableVia Valerio Lorenzo, 5b -Torino
Tel. +39 327.739.5709
Il sito web