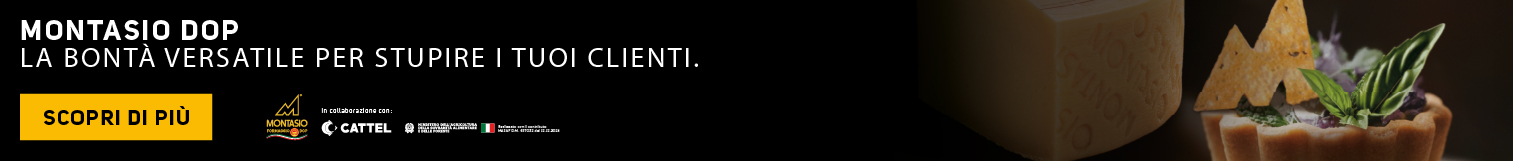Non solo allergeni: a Montreal il menu del ristorante cinese Aunt Dai agisce come strumento di captatio benevolentiae, instaurando un dialogo virtuale fra il ristoratore e l’ospite, tanto accattivante quanto sincero.
La Notizia
A cosa serve un menu? La domanda non è nuova, la risposta tuttavia oscilla fra diverse istanze. Perché se è vero che ogni ospite ne trae le informazioni necessarie per compiere la propria scelta, i ristoratori smaliziati possono ben servirsene per orientarla a proprio favore, in modo da far girare prodotti stantii o vendere a margini più vantaggiosi.
Ha fatto scalpore il caso di Aunt Dai, raccontato su Forbes da Leslie Wu. Il ristorante, che opera da sette anni a Montreal, ha fatto dell’ironia e dell’understatement la sua arma vincente, diventando virale sul web. “Molte persone desiderano primeggiare, ma noi semplicemente non siamo i migliori. Cerchiamo solo di migliorarci un po’ ogni giorno”, ammette candidamente Feigang Fei, ex ingegnere informatico convertito alla ristorazione, che si presenta agli ospiti come uno di noi.
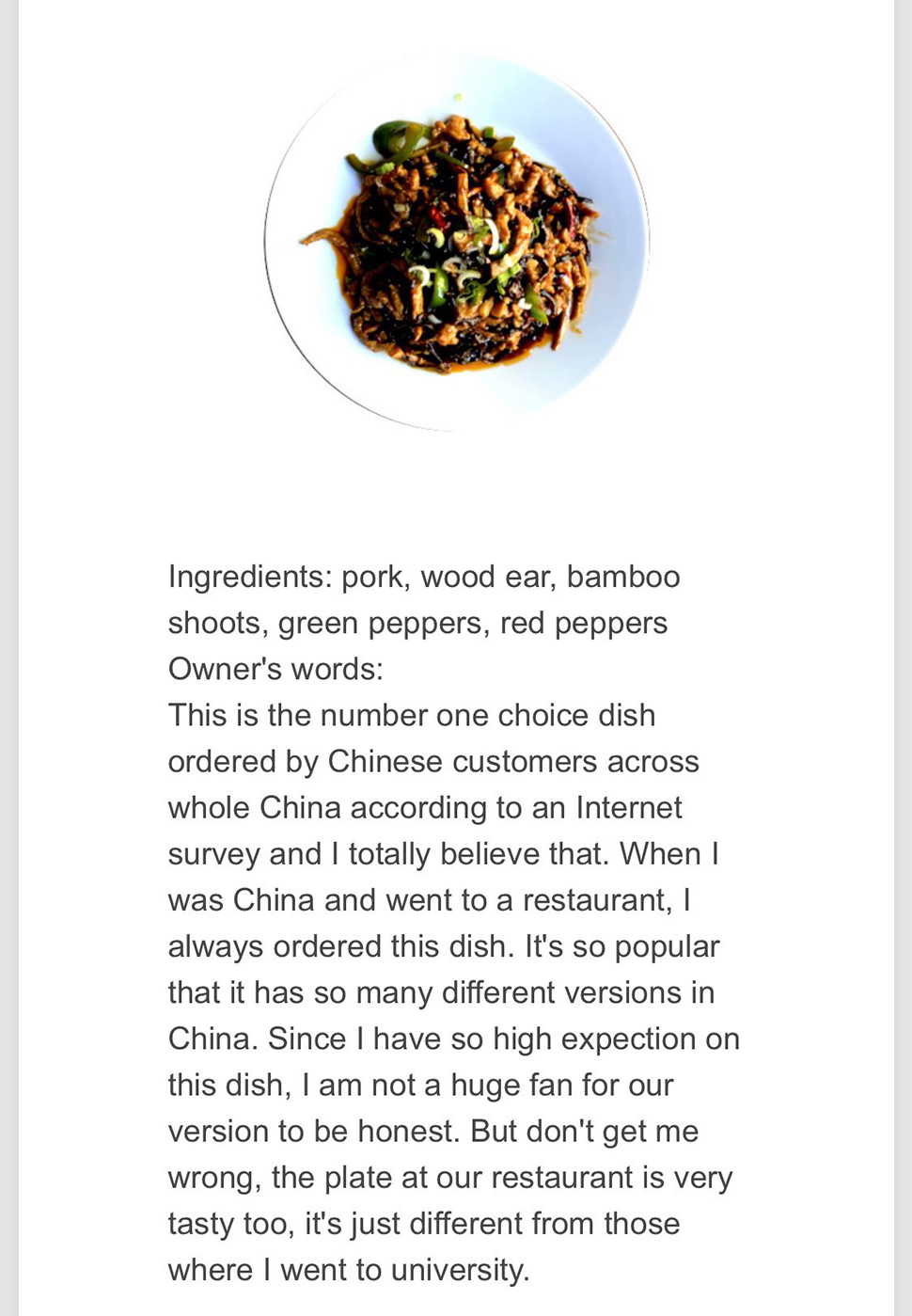
Le descrizioni dei piatti sul sito auntdai.com, con la loro premurosa confidenzialità e il loro stile colloquiale, strappano il sorriso. A proposito della zuppa Suan La Tang si legge “Speziata e saporita, senza carne, da bere piano per evitare il singhiozzo”; mentre sui Singapore noodles “Sanno di curry, non aspettarti che siano così saporiti, ma è una scelta sicura e ti farà felice”. Altrove Feigang sembra quasi giustificarsi umilmente, ricorrendo alla prima persona: “Ci sono tanti piatti cinesi che sono deliziosi, ma volendo essere onesti, è un dilemma per il ristoratore resistere all’impulso di metterli tutti in carta. Quando il menu è gigantesco, diventa difficile garantire la qualità. Devo combattere l’idea di fornire una maggiore scelta in nome della massima qualità possibile”. Può trattarsi anche di prevenire altre critiche, relative alla scarsità di ingredienti pregiati: “I clienti mi dicono che ci sono pochi germogli di bambù in questo piatto e sono d’accordo. Ma non sapete quanto costano questi germogli. Penso che servano solo per il profumo e per il nome del piatto”.
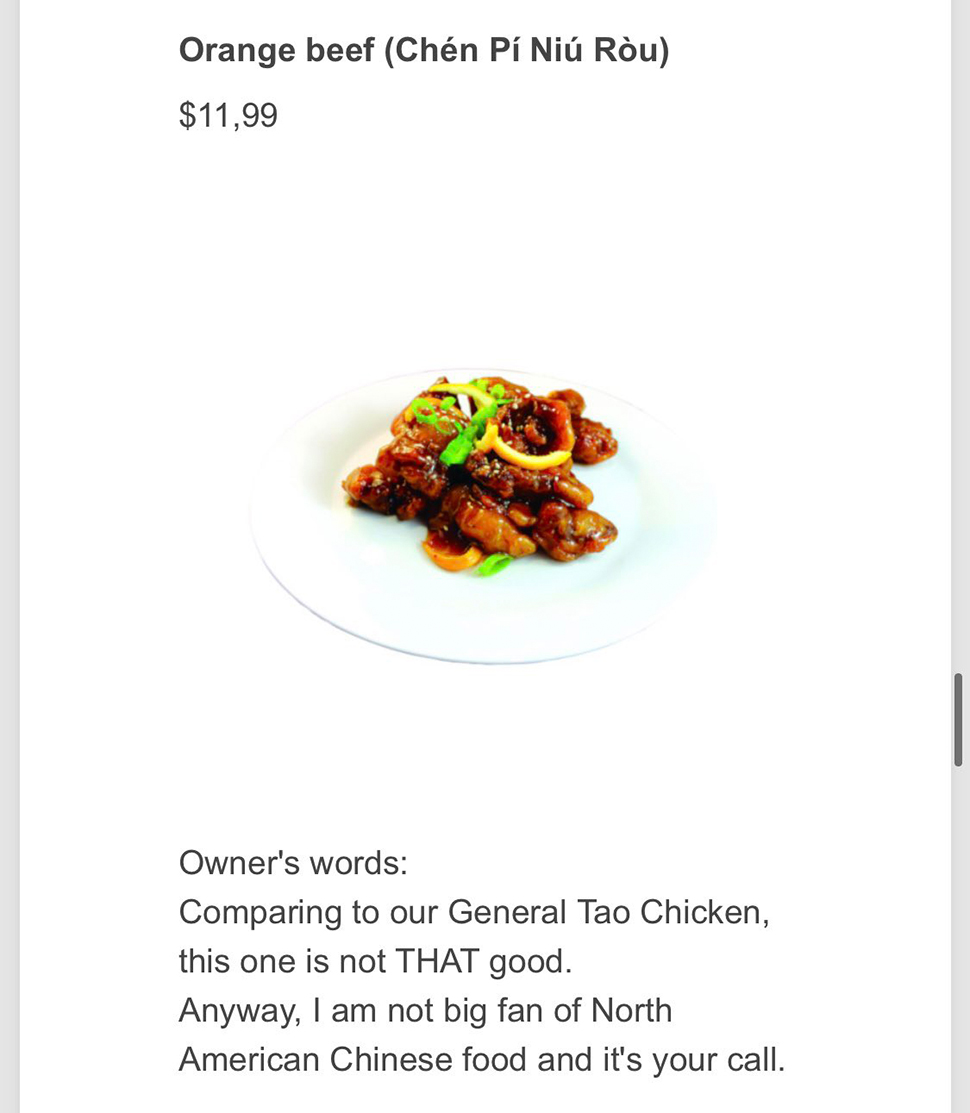
Oppure di facilitare il lavoro dei camerieri, per esempio spiegando che certe ricette vengono servite in versione vegetariana, affinché questi non siano costantemente assillati dalle delucidazioni. Ma c’è anche un piatto, Satay sauce beef, di cui candidamente ammette: “I clienti dicono sia molto buono, ma non ho ancora avuto l’opportunità di provarlo. Sembra che io debba trascorrere più tempo mangiando nel mio ristorante”. Fino a sconsigliare addirittura la scelta del manzo all’arancia: “Rispetto al nostro pollo General Tao, non è COSÌ buono. In ogni caso non sono un grande fan della cucina cinese nordamericana ed è la tua scelta”.
Nella descrizione dei piatti, oltre alle indispensabili informazioni di base sull’ingredientistica, compaiono notazioni e sensazioni captate da clienti comuni, non particolarmente ferrati, che accomodano l’ospite su una poltrona più alta. Vedi Hei Jiao, manzo al pepe nero, di cui si legge: “Non fatevi ingannare dal nome, questa non è autentica cucina cinese. È una storia vera, un cliente è diventato matto perché non è così cinese, dal momento che aveva visitato Sichuan in precedenza”. Tanto che il riferimento geografico è stato cancellato dal menu, “eppure il piatto resta delizioso secondo molti clienti”. Lo stile non cambia nel blog del ristoratore, che compie una sincera autocritica a proposito di sfortunati tentativi di ampliamento, imputandone l’insuccesso all’avidità e al desiderio di guadagno immediato, a scapito della qualità.
Fonte: Forbes