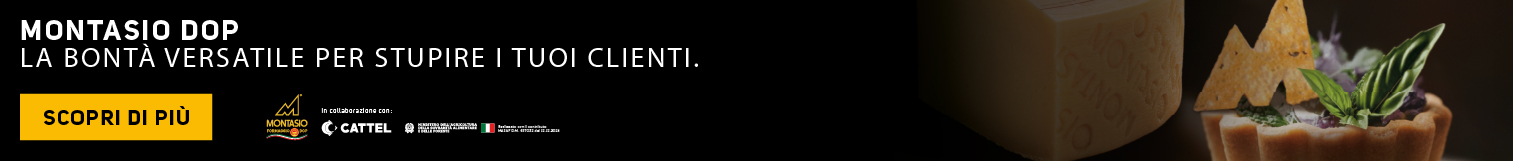“Da noi venivano a mangiare i grandi chef di Francia e di Germania, ma anche tanti artisti, come Andy Warhol. Arrivava più gente da New York che da Bologna.” Ancora una grande storia della cucina italiana, quella di Giacinto Rossetti e del suo Trigabolo.
La Storia
Come definire Giacinto Rossetti? Un ristoratore totale, alla guida di una delle cucine più dirompenti della storia italiana; soprattutto un sognatore e un visionario, tanto lucido quanto disincantato, a tratti perfino disperato e purtuttavia indomabile. Le sue sono state tre stelle in pectore, comunicate per così dire a babbo morto, quando gli eventi avevano travolto il Trigabolo, irripetibile laboratorio di un’audacia sfrontata. Pescatore in Polonia e poi cuoco di un privato, oggi pensionato, parla come il profeta di una cucina che ha appena sfiorato il pianeta.
“Vengo da una famiglia di commercianti, per l’esattezza in profumeria bassa. Perché allora c’era chi vendeva da Elizabeth Arden in su, e aveva il negozio, e chi vendeva da Elizabeth Arden in giù, come i miei, che facevano gli ambulanti nei mercati. Mia mamma Concetta era siciliana e cucinava benissimo certi piatti meridionali, dagli spaghetti alla Norma ai polpettoni; si era specializzata anche come sfoglina, sviluppando da dilettante una diversa forma di attenzione. In tutto questo io, che sono nato nel ’48, appena rientrato dal militare ho sviluppato l’idea di fare qualcosa che avesse a che fare con l’alimentazione, per la necessità di non prendere ma dare e incontrare l’uomo. L’università no, non l’ho mai considerata, da bravo pasoliniano sposavo le sue modeste proposte di abolire la scuola dell’obbligo e la televisione. Per me era tempo perso, e avevo ragione.
È successo che ad Argenta ho trovato un locale in vendita sulla piazza e dopo un paio d’anni sono riuscito a prenderlo. Ho aperto un ristorante che all’inizio era una pizzeria, perché il comune aveva combinato la sua solita cazzata, passandomi la licenza che già c’era; ma dopo aver perso la causa ha dovuto autorizzarmi a fare le mie cose, soprattutto cibi tradizionali. Io fin da subito ho iniziato a spingere sull’acceleratore, con l’ambizione di proporre cose che in Italia non c’erano. Mi era già chiaro come il primo argomento della cucina italiana fosse la reperibilità delle materie nobili. E a quei tempi la zona era ancora più difficile, massacrata da una nebbia onnipresente, che adesso non c’è più.
Io giravo senza sosta per produttori, artigiani, cuochi, vignaioli. Volevo capire cosa fossero il vino e il cibo. In quel momento il meridione stava cercando di aprire qualche finestra sul mondo, il Barolo iniziava a diventare un grande vino, ma il Barbaresco se lo bevevano tutto in Langa, mancava una rete commerciale. E io viaggiavo, compravo vini e materie prime. Già mi colpiva l’infamità di dar credito solo ai super stellati, mentre scoprivo migliaia di piccole esperienze, gente che serviva coscienziosamente la carne cruda o il vitello tonnato, le grandi carni, il bollito, il tartufo usato con criterio. Andavo tanto da Guido, che era una cosa seria, che in molte trattorie, soprattutto piemontesi. Perché già allora la Lombardia mi sembrava spavalda e cittadina, anche se magari elaborava progetti più solidi, perché dipendenti dall’uomo anziché dalle materie prime, mentre la cucina stava imboccando la strada della spettacolarità e dell’essere mercato.

Marchesi era già un maestro, intelligente, colto, aveva concepito una cucina per la città, che però non gli è bastata. Ma Guido era proiettato in un nuovo umanesimo. Poi c’era Veronelli, che era molto affezionato a me. La prima volta che era passato a mangiare ci aveva subito dato il suo sole. Era rimasto colpito da tutto, fino all’essenza filosofica. È stato un uomo gigantesco: la sua lettura anarchica dell’indole banditesca dello stato, che già allora faceva sfracelli, è tuttora attuale. Corrisponde a una verità che non si è mai realizzata.

Con me c’erano la sfoglina Gianna, quasi subito Igles Corelli e Bruno Barbieri. Ragazzi giovani, che in fretta hanno capito come l’anarchia consentisse loro di realizzare i propri sogni. Potevano fare tutto quello che volevano, mentre io correvo senza sosta a procurare roba da mangiare. Ed è la massima difficoltà del mestiere, poi il cuoco dovrebbe essere un umile servitore della materia, anche se è diventato un divo della pellicola. Quindi la selvaggina e le sue uova, che sono la cosa più sana di questo mondo, le rane, ma non quelle turche, i pesci di acqua dolce delle nostre valli e quelli del nostro mare, le anguille e il riso di qui, che è un po’ salato. Portavamo a casa materia nobile due volte al giorno, ma già allora era vietata dalla legge. Si poteva solo comprare roba industriale, prodotti di allevamento che confluivano in una cucina di allevamento, cattiva come la cattività. Ormai si è perso tutto. Bisognerebbe prendersi dei polli a collo nudo, allevarseli e mangiarli a 90 giorni, tenendo le ovaiole per le uova. Le anatre selvatiche non si possono mangiare né mettere in frigorifero. Non credo neppure nell’abbattimento selettivo, perché l’umidità della caccia è sangue, bisogna ammazzare gli animali in un certo modo, tenerli in frigorifero, pelarli… Tutte cose vietate. Abbiamo finito le pesche bianche, che durano troppo poco per la grande distribuzione: le vado a cercare a casa di qualche contadino, che ha ancora un albero o due. E con i San Marzano abbiamo perso un colore della bandiera. Ci restano solo le canocchie.

Noi facevamo ammazzare i caprioli e i cinghiali, usavamo le alzavole, i magassi, le folaghe, carni macellate in una maniera impossibile, avevamo i pastori per gli agnelli, chi allevava faraone… Sapevamo che tutto questo era illegale, ma lo facevamo lo stesso. Finché non ci ha centrato un Caterpillar: il sindaco di Argenta ci ha fatto chiudere, con richiesta di riapertura a norma e costi di adeguamento inaffrontabili. Tutto perché avevamo due beccacce sottovuoto con le penne in frigorifero. Due. Nemmeno fosse stata Piazza Fontana. Ma forse davamo fastidio ai ‘paesani’. I nostri piatti? Il risotto con le folaghe, i ravioli di faraona con lo zabaione di Parmigiano, il pesce di giornata… Eravamo tecnologicamente avanzati, grazie a Igles che aveva una marcia in più e a Saperi e Sapori, un congresso ante litteram. Da noi venivano a mangiare i grandi chef di Francia e di Germania, ma anche tanti artisti, come Andy Warhol. Arrivava più gente da New York che da Bologna.
A quel punto però mi sono arreso: se non era possibile cucinare così, meglio chiudere. Per 3 anni ho pescato lucci in Polonia. Poi un cliente abituale, industriale bolognese dell’alluminio, mi ha assunto come cuoco privato. Cucinavo a casa sua due o tre volte a settimana, altrettante per i clienti in montagna, tutto solo, per cameriere un guardiacaccia. È durata 18 anni, poi sono andato in pensione con 530 euro al mese. Come mangio a casa mia? Oggi i cappelletti, domani i tortelloni con le ortiche. Cucino per me e per qualche amico, con quello che trovo dai contadini. Quelli del Trigabolo non ci sono più, sono invecchiati, non hanno voglia di impazzire con gente come me, che vuole capire cosa c’è dietro una gallina. Non possono allevare i maiali in casa e aspettare 6 anni per un prosciutto, per loro non ha senso.
Nella mia cantina ho soprattutto Barolo, il vino numero 1 del mondo, senza un numero 2 che sarebbe solo il Barbaresco, mentre il pinot nero mi piace meno di un tempo. E poi Sangiovese di Romagna, un po’ di Marche, qualche miracolato di Dio che non cambierà mai. I bianchi in Italia non ci sono, tranne qualcosa sull’Etna o in Friuli; bisogna andare in Borgogna o sulla Mosella. In tutto possiedo un migliaio di bottiglie, ma adoro anche il whisky. Rappresenta il senso del tempo, del sapore, della luce, della sapidità, del fermentato, dell’acido. E seguo Baldo Baldinini.

Sono 50 anni che seguo il vino: per me è un matrimonio d’amore con la cucina. Ma hanno entrambi imboccato la strada della spettacolarizzazione, con disastri incommensurabili. Anche se ci sono ragazzi che hanno preso in mano le loro situazioni e con la materia prima fanno cose interessanti. Il più bravo di tutti è Filippo Volpi, il suo Bioselvatico è una follia, difficile in zona ottenere di più. Anche se quando cade una bottiglia, lì si riempie di olio da sola. Invece fra i cuochi il migliore è Remo Camurani, che è in una fase di evoluzione sconvolgente. Ma non è l’erede del Trigabolo: lui è lui, con la sua tenerezza, intelligenza, cultura. Continua rabbiosamente a fare ciò che non potrebbe, girando per le colline romagnole. Altri sono bravi, ma quando fanno da mangiare non pensano alla storia del loro paese, al cibo come incontro con l’uomo, alla misura della modificazione della materia. Fanno i piatti che piacciono a loro, mentre la cucina dovrebbe essere una storia d’amore, l’incontro fra la filosofia comportamentale del cuoco e uomini in cerca di rispetto. Adesso il mondo è finito, finalmente sono crollate tutte le certezze, nessuno conosce più la verità. Potrebbe essere il preludio di qualcosa.”