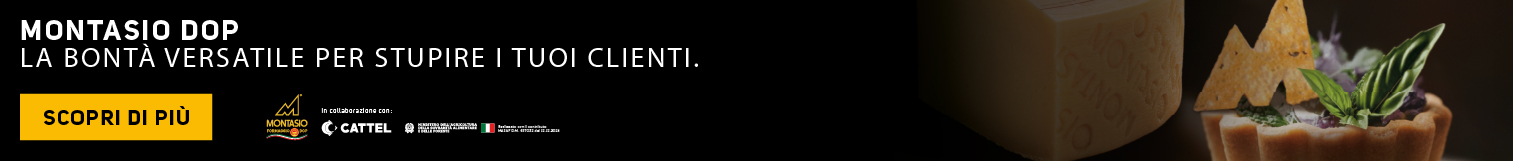I signature dishes? La prigione dorata degli chef e il comfort food del pubblico. L’opinione dei grandi cuochi sull’alta gastronomia del futuro.
Il tema
Una “delizia” tanto dolce e anelata e una “croce” che, a volte, tarpa le ali e cede il passo alla monotonia: questo sono i signature dishes per molti chef. Una riflessione che trascende la mera cucina e diventa una vera e propria questione filosofica e psicologica, che ritrae la doppia faccia della medaglia "esposta" da tutti coloro che firmano una pietanza iconica. I piatti d'autore, massima espressione della creatività e del talento di uno chef, spesso, finiscono per intrappolare quella stessa creatività da cui sono scaturiti e si trasformano in una cicatrice indelebile e nel seme delle aspettative dei commensali. I piatti iconici rappresentano, sì, la firma e l’identità di uno chef, ma in un dato momento della carriera. Sono visti come il porto sicuro e rassicurante da pubblico e critica, ma per gli chef, come tutte le confort zone, finiscono, poi, per rivelarsi scomode.

I signature dishes sono un traguardo, ma anche una trappola per il processo di evoluzione di ogni artista del cibo. “Creiamo per noi stessi, ma il riconoscimento arriva dal pubblico. Tuttavia, questo riconoscimento può congelarci in ruoli che non avevamo previsto”, racconta Pierre Gagnaire a Food and Sense. Il piatto diventa, quindi, l’insegna del ristorante e l'alter ego dello chef che si trova obbligato a ripetere impeccabilmente e “meccanicamente” la sua eccezionale performance. “Ripetere un piatto ancora e ancora significa privarsi del diritto di sbagliare, di fallire, di provare qualcosa di nuovo”, spiega René Redzepi. La creazione che ha consacrato lo chef si trasforma, perciò, in una dittatura della perfezione che soggioga la libertà d’espressione. “Ogni piatto d'autore deve essere come una partitura magistrale. Ma quanti direttori d'orchestra finiscono per interpretare questo ruolo senza voglia, semplicemente per dovere?”, commenta Alain Ducasse.
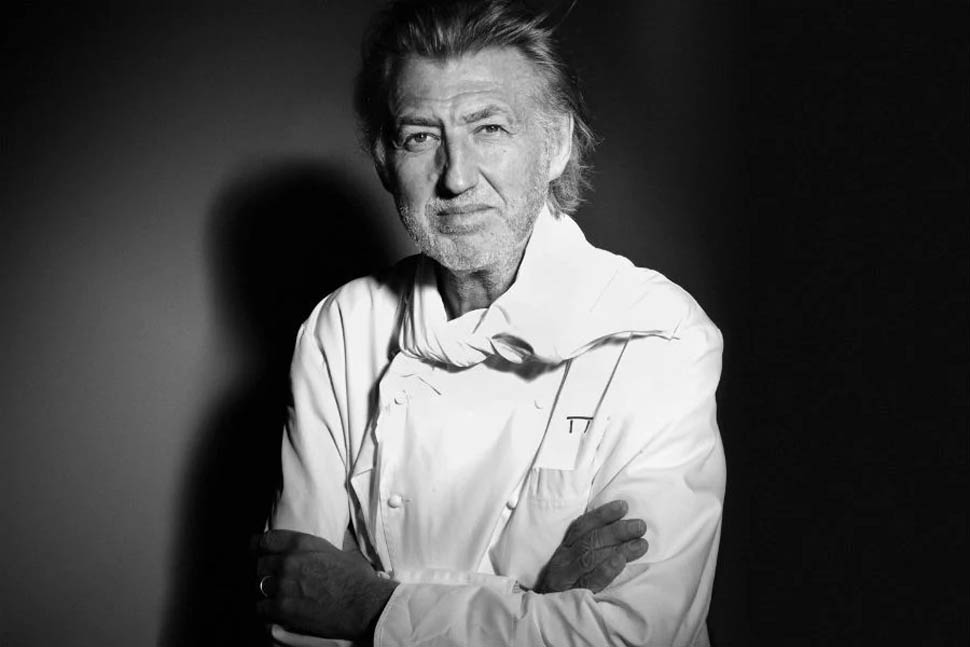

Una prigione dorata costruita non solo dalle aspettative dei commensali, ma anche dalla critica, dalle guide e dai social media, finendo, così, per abbracciare la sfera economica. Spesso, infatti, è proprio il piatto d’autore ad essere il volano delle prenotazioni e della fidelizzazione della clientela. “Diventa un contratto morale con il pubblico. Rappresenta una promessa e dobbiamo mantenerla, anche se finisce per appesantire”, spiega Alain Passard. “Creare un piatto per se stessi è l'inizio dell'arte, ma creare un piatto per conservarlo significa già accettare che non ce ne distaccheremo più. Il piatto d'autore è tanto una fonte di reddito quanto un peso. Lo manteniamo per necessità, ma a quale costo per l’innovazione?”, aggiunge Yannick Alleno. Il piatto iconico diventa, quindi, il sottilissimo e delicato confine fra tradizione e innovazione, ancorando l’estro dello chef al passato. “Il piatto d'autore è un faro, ma è anche un punto di riferimento che delimita gli orizzonti. Impone una fedeltà al passato, una sorta di nostalgia per quello che eravamo, anche se la cucina è un linguaggio del momento”, confida Andoni Luis Aduriz .


“Il gargouillou (suo piatto iconico) è diventato la nostra firma, ma quante volte ho voluto trasformarlo radicalmente, senza mai osare veramente?”, racconta Michel Bras. Il piatto d’autore si presenta quindi come una canzone ripetuta in loop, un inesorabile dejavu. “La cucina è un gesto effimero, quando è congelata in un piatto d'autore, diventa una collezione, un oggetto del passato”, conclude Michel Troisgros.