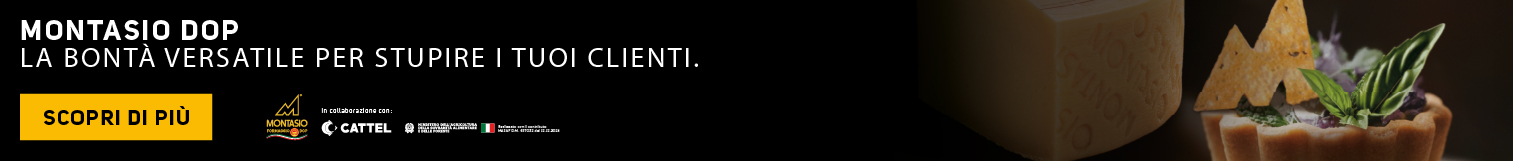Tecnica e immaginazione, pulizia e gusto fanno di Anthony Genovese uno dei migliori cuochi della capitale, e non solo
La Storia
La Storia di Anthony Genovese
Via dei Banchi Vecchi 129/a, Roma. Non offre molti indizi, dal marciapiede sulla strada trafficata, il ristorante Il Pagliaccio, se non la targa dorata dei Relais & Châteaux, che riflette pigre seggiole fuori dalla vineria antistante. Eppure da qui si accede “anywhere out of the world”, per dirla con Baudelaire: “N’importe où! N’importe où! Pourvu que ce soit hors de ce monde”. In una cucina free style che sorvola l’Eurasia, ben distante dalla voga fusion che attanaglia Roma caput food.


Lo chef Anthony Genovese, fra i migliori della capitale e non solo, l’ha tenuto chiuso per 5 mesi: dopo 14 anni di fuochi sempre accesi, culminati nell’ottenimento della prima e della (meritata) seconda stella Michelin, la cucina, priva di Roner e di forno performante, reclamava un restyling, in cui ha trovato posto l’amata piastra teppanyaki. Mentre le salette restano quelle di sempre, anche perché ogni centimetro del centro storico è vincolato, con i pavimenti a scacchiera e le pareti rosse dal richiamo pompeiano, a contrastare il giardinetto interno che si disegna sullo sfondo: umbratile e attorcigliato come un oriente da camera.

Luoghi che raccontano un percorso, ancor prima dei piatti, come la spirale di una chiocciola. Quello di uno chef partito dalla Francia, dove il nonno messinese era emigrato per lavoro, posando la frusta da pasticciere per sollevare la cazzuola, e svezzato ai sapori di casa del nostro meridione in Alta Savoia. Formatosi alla grande scuola francese, dapprincipio all’alberghiero di Nizza con un professore d’eccezione quale Jacques Maximin (colui che disse ad Adrià: “Creatività è non copiare”), severo maestro di grandeur; poi con Dominique Le Stanc, allievo di Chapel e Senderens, a Eze Village e Gérald Passedat al Petit-Nice di Marsiglia. Tanto che le basi classiche, nella composizione delle ricette e nei fondi, restano ben salde.


“Io però mi sentivo italiano. Così anche se i colleghi mi chiedevano cosa tornassi a fare, forse gli spaghetti, ho rifiutato un posto di capo partita da Ducasse per lavorare da Pinchiorri, dove a stretto giro è arrivato Carlo Cracco. Ed è stato grazie all’Enoteca che ho iniziato a conoscere l’Asia, fermandomi per un anno a Ginza, Giappone. Ci sono tornato dopo tre anni a Londra, per la precisione al Mandarin di Penang, Malesia. Piattaforma da cui mi sono allargato a Singapore, Hong Kong e Pechino, girando per i mercati e mangiando nei ristorantini. Ricordo che proprio vicino a casa mia c’era una piantagione di noce moscata, ne spremevano i frutti e bevevano il succo. Inebriante. Non finirò mai di studiare le spezie, per quanto le usi con parsimonia, e in particolare il pepe”. L’Asia di Genovese non è infatti circoscritta ai cliché correnti di dashi e katsuobushi, spesso poco integrati nel piatto: del continente esplora piuttosto le pieghe riposte, dalla Cambogia al Laos. Profumi, ingredienti, marinature ma soprattutto una voglia di leggerezza e liquidità, integrità e freschezza.
Il Ristorante


“Fusion però è una parola che odio”, puntualizza Genovese. Non a caso la riapertura del Pagliaccio è avvenuta sotto il segno di Parallels, un progetto prima ancora che un menu. Allude come sempre agli assi terrestri che quadrettano la cucina, ma anche alle concordanze con la sala, soprattutto grazie agli abbinamenti ideati da Matteo Zappile, restaurant manager e sommelier (insieme a Luca Belleggia), che affianca Genovese da 8 anni. È sua la carta dei vini da 1400 referenze, i cui vanti sono la profondità in verticale e le sezioni straniere. Ma ci sono anche una proposta al calice (5 bianchi e 5 rossi, di cui 2 grandi maison, 2 piccole e 1 scelta del giorno), la carta dei sakè, sparkling compresi, e una carta delle birre in allestimento. Il percorso di abbinamento non è precostituito, ma sartoriale, e non si limita al vino, ma si configura piuttosto come un beverage tasting. “Perché il vino su questo tipo di cucina mostra qualche limite. Inoltre nella sequenza cerchiamo di contenere l’alcol, che abbinando un calice per piatto si impenna. Quindi preferiamo partire con una bollicina, passare a un bianco, poi magari a un sakè o a una birra, che sono più leggeri, per concludere in certi casi con un infuso. Ma dipende tutto dall’ospite. Una volta che la cucina ha messo a punto il piatto, questo passa in sala, dove lo assaggio con Luca Belleggia e Laura Braggion. Formulo così la mia proposta di abbinamento, che sottopongo allo chef”.

Soprattutto Parallels evoca i due staggi che il ginnasta afferra per compiere i volteggi più leggeri, ora vicinissimi, ora asimmetrici e decalati. I tendini tesi per fluttuare nell’aria, senza mai toccare terra. Sono la cucina classica e l’Asia: parallele utili per il gioco dell’immaginazione. Portano espansione e contrazione, addizione e riduzione. La pulizia esemplare di una cucina bipolide, che previene qualsiasi assuefazione.

L’attenzione è anche sulla materia: la carne della Bottega Liberati, il pesce in arrivo da quattro fornitori, basati in Francia come ad Anzio, con il sogno ancora irrealizzato di un orto proprio. Nella loro elaborazione conta prima di tutto la freschezza, quindi una linea che viene rifatta quasi ogni giorno, l’uso del sottovuoto solo per le marinature e la conservazione, il ricorso limitato all’abbattitore, la predilezione in cottura per fiamma e padella. “Perché cerco la purezza del prodotto attraverso la tecnica. Ma per me resta primordiale l’uso delle mani: mi piacciono il profumo della carne e del pesce nell’aria, toccare, bruciacchiare, infornare; perfino schiumare un brodo è bellissimo. Io senza cucina non so stare”.


E proprio Parallels si chiama il menu degustazione di 10 portate da 170 euro, cui fanno concorrenza gli 8 classici de Il Pagliaccio a 150 (fra cui l’ostrica e la pasta con stoccafisso e ‘nduja) e la carta; a pranzo anche una formula composta di 3 piatti a 75 euro. “Funziona così: io propongo le linee generali e gli ingredienti su cui concentrare l’attenzione; poi studio i piatti con tutta la brigata, a cominciare da Francesco Di Lorenzo, secondo che mi affianca da 11 anni, provando e riprovando. Sono molto aperto: mi piace essere provocato”.
I Piatti



Si comincia con diversi invii di appetizer: il cestino super sabbiabile di pasta kadaifi con sgombro e ananas, la spuma di mais con agrumi e curry, il cracker cacio e pepe per il contro stornello romanesco, la crema di ceci con acciughe essiccate coreane, il pane al vapore con pomodoro e mozzarella, il cubo di Parmigiano lavorato a 70 °C con macis e chiodi di garofano, servito freddo e impanato di lievito secco per un’inversione del toast, la tartelletta di riso nero con lenticchie, formaggio erborinato e nero di seppia. Dove emerge la predilezione per i legumi, trait-d’union fra Italia e Asia.

Il benvenuto lascia li segno: si tratta di nasello crudo nappato di jus di pollo alla senape, secondo la classica associazione fra pesce e carne bianca, abbinato a un cilindro di albume montato con poco sale e zucchero, poi rassodato al vapore stile oeuf à la neige e acidulato al frutto della passione, per guarnizione una lamella di finocchio arrosto in contrasto. Dove è la similitudine fra le prime due testure a risaltare, grazie al passaggio del filetto in salamoia e al taglio spesso a sashimi, parallelo alle fibre. Cosicché quello che sarebbe un difetto (la polpa fragile, che altrimenti perde carnosità) si ribalta in pregio e cuore del piatto. Ma l’accostamento compone anche un soufflé di pesce in due tempi, conciliando pulizia gustativa e leggibilità concettuale: il taglio è orientale, il retroterra francese.

Un classico di Genovese è il Viaggio, foie gras marinato per 48 ore nel miso rosso invecchiato nel legno di ciliegio, abbattuto e affettato a crudo. Viene servito senza sale con fettine di ricciola in tataki, appena segnata sulla piastra (“abbiamo provato altri pesci, ma questo regge meglio la grassezza del fegato”), un battuto al Pacojet di arachidi, tamarindo e lemongrass per rinfrescare. In abbinamento Zappile non propone vini dolci o Champagne, ma una birra che ne emula le sensazioni liquorose: la Xyauyù Baladin, per la dolcezza dovuta al passaggio in legno.

Ma c’è anche la battuta di pecora, carne morbida e dolce, corretta per via tattile dalla sensazione ispida della foglia di sesamo coreano che la avvolge. Viene servita in una quasi-tartare con tuorlo cremoso di quaglia, probabilmente congelato, caviale iraniano e bulgur croccante, in insalata e soffiato.

“Avevo un’idea riduttiva della pasta secca, non da grande ristorante. Ma non ho resistito a questi fusilli Gerardo Di Nola, così carnosi, con un gusto tutto loro. La ricetta però resta diversa dalle altre: più golosa e italiana. Con i cannolicchi per raddoppiare la testura tenace, la crema di porri e mandorle fresche, due ingredienti che adoro, le lumachine di mare o bigorneaux bretoni”. Per un esito goloso, da scarpetta. Il suggerimento cade su Mareneve di Federico Graziani, per la complessità, l’acidità e le note salmastre.

Virano quindi dalla sapidità alla dolcezza, in direzione Francia, i tortelli di carote e vitello, binomio di un classico spezzatino d’Oltralpe, irrorati di brodo di vitello aromatizzato al fieno appena bruciato, messo in infusione e filtrato. 1

Per secondo un altro salto sulle parallele fra Asia e Francia: l’anatra di Bresse, ma quasi-laccata alla pechinese, con la pelle cosparsa a più riprese di acqua bollente per sgrassare e nappata di una miscela di glucosio, Sherry, camomilla e spezie, “perché la ricetta originale è troppo complessa sotto il profilo tecnico e dell’attrezzatura”. Viene servita con una miscela di sali e pepi, limone iranano, mandorla tostata e grano saraceno; un involtino di coscia sfilacciata nella pasta phyllo e una cassolette di rigaglie con fagiolini e taccole.

Prima del dessert, come classicità comanda, arriva “La nostra idea di formaggio”, composta in questo caso di gelato fiordilatte, spuma di caprino, cereali tostati e pera. Lo chef pâtissier è francese, con trascorsi all’Enoteca Pinchiorri: si sente nel biscotto pain de Gênes con gelato allo shochu, distillato giapponese di cereali e riso, lamponi e burro all’arancia. Un dolce senza spigoli, la cui morbidezza si prolunga nel Teos di Poggio al Tesoro, petit manseng paradossalmente scelto per la sua scarsa acidità.

Fotografie di @AromiCreativi
Indirizzo
Ristorante Il PagliaccioVia dei Banchi Vecchi n 129/a - 00186 Roma
Tel. +39 06 6880 9595
Il sito web