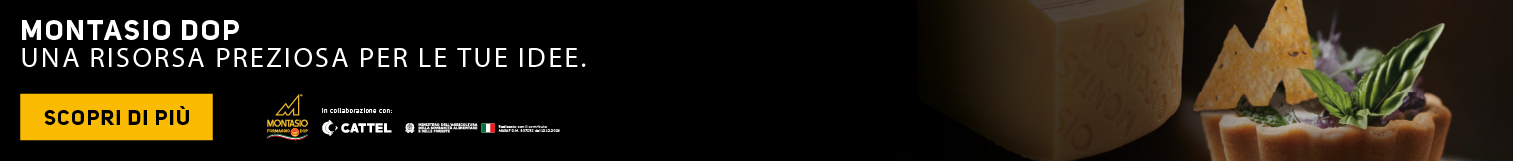È la storia di tanti giovani cuochi che dall’Italia hanno conquistato le cucine più prestigiose del mondo. Fra di loro c’è anche lui, il foggiano Fabio Stridi.
La Storia
Prendere il primo treno per l’alta cucina, destinazione ignota, con pochi spicci in tasca e un bagaglio che scoppia di passione. È la storia di tanti giovani cuochi che dall’Italia hanno conquistato le cucine più prestigiose del mondo. Fra di loro c’è anche lui, il foggiano Fabio Stridi, classe 1986. Che da raccontare ha tutto un romanzo di formazione, la cui morale dice qualcosa sul futuro della ristorazione in un momento epocale.
“La cucina mi è sempre piaciuta”, esordisce. “La famiglia di mia mamma portava avanti un’azienda agricola: non solo l’orto, ma le conserve, le capre e le vacche per i formaggi, il vino e qualche salume. Un’energia che mi ha folgorato, quando ho infilato le mani nella terra a 5 o 6 anni. Lei e la nonna erano bravissime: ogni giorno c’era un calderone sul fuoco con qualcosa di buono, che fossero i cavatelli o le braciole al sugo. E io ero curiosissimo di alzare il coperchio. Sono state loro a farmi capire che il cibo non serviva solo a sfamarsi, ma era un veicolo di convivialità e di piacere. Poi c’era mio zio, che aveva aperto una trattoria, nella quale ho iniziato a dare una mano a 12 anni e che oggi mi piacerebbe riprendere in mano. Cosicché finite le medie, gli insegnanti mi hanno consigliato di non proseguire gli studi, ma io volevo fare il dottore o il cuoco. Mia mamma, siccome erano 9 fratelli e i soldi scarseggiavano, mi ha detto: vai in cucina, così inizi subito a guadagnare da tuo zio. E così è stato”.

“L’ambizione però era già tanta, al limite dell’arroganza: mi prefiggevo da subito di diventare uno dei migliori chef al mondo. Quindi cercavo una buona scuola alberghiera e a quei tempi Vieste eccelleva. Per pagarmi la retta, siccome era semiprivata, d’estate lavoravo. Alla scuola chiesi di andare al Grand Hotel di Rimini, che compiva un secolo. Erano 45 cuochi e ho passato la prima settimana a spazzare per terra e lucidare i piatti con l’aceto, senza toccare una patata. Tornato a Foggia per amore, sono approdato al Ventaglio, che all’epoca aveva una stella: in cucina eravamo io e la chef Sabina Ficco, con il figlio in sala. Mi insegnava i piatti tipici e la mattina andavamo insieme al mercato, senza scorte. Poi c’è stato Leonardo Vescera, che era stellato al Capriccio, nelle vesti di panettiere e pasticciere”.

“Per vedere altro sud mi sono recato alla Trattoria di Monte Costone di Ilario Vinciguerra, al colloquio avevo già le valigie per restare. Anche lui faceva la spesa ogni mattina e mi ha fatto conoscere personalità come Corrado Assenza, Gerardo Di Nola, Antonino Cannavacciuolo. A quel punto è stato un amico foggiano, Remo Capitaneo, a consigliarmi di salire ancora un gradino al Met di Corrado Fasolato, dove ho trascorso due anni e mezzo, da commis agli antipasti fino a capopartita ai secondi: ed era una cucina che non avevo mai visto, un mix di nord Italia e influenze asiatiche, che mi piaceva moltissimo. Sempre Remo, il mio mentore, mi ha detto che sia Crippa che Berton stavano cercando un cuoco. Volendo approfondire primi e risotti, ho scelto il Trussardi. Ed è stato come fare il militare. Erano ricette marchesiane, i brodi, i consommé, tutto con una materia prima mai vista. Un sogno, ma durissimo. Berton era al pass, assaggiava tutto, poi a impiattare erano Luigi Taglienti e Roberto Conti. Uno squadrone. Ricordo che il primo tagliolino al tartufo bianco che preparai non andava bene e mi lanciò addosso tutta la padella con la pasta e la salsa”.

“Facevamo molte cene a quattro mani ed è stato così che ho conosciuto il mio maestro in pasticceria, Gianluca Fusto, chef come Alex Atala e Stefano Baiocco, che era stato dappertutto e faceva una cucina eclettica, dalla Francia alla Spagna, dalla Scandinavia al Giappone. Passai a Villa Fetrinelli: la mattina andavamo presto nei giardini con la lista dei fiori e delle erbe da raccogliere. Ed è stato lo chef più organizzato, ma anche il primo calmo che ho incontrato. Io però volevo assolutamente entrare in un tre stelle, inviavo curriculum ma niente, avevo quasi finito i soldi e allora che ho fatto? Ho ritirato gli ultimi 300 euro che avevo sul conto, ho infilato nella valigia i coltelli con le divise e ho preso il primo treno che ho trovato: Venezia Zurigo”.

“Appena sceso, però, mi sono reso conto che non parlavo tedesco e sono andato a Ginevra da un amico, che ha diviso il letto con me per un mese. Sognavo Ducasse, Pic, Troisgros, ma nessuno rispondeva ai miei curriculum. Finché un giorno ho ricevuto una mail da un ristorante di Annecy, Le Clos des Sens, allora sotto la guida di Ducasse. Dopo la prova mi hanno assunto come capopartita al pesce, ricordo in particolare le capesante vive, le salse preparate due volte al giorno e il burro dappertutto. Il riscatto del grasso. Poi Le Floris di Ginevra per la carne, dove dormivo in una camera dal contadino che forniva al ristorante le uova. Alle sei meno un quarto mi svegliava il canto del gallo e nelle ore libere rientravo per dare una mano in campagna, dove rivivevo l’infanzia. Claude Legras mi ha insegnato a cuocere carne e selvaggina, oltre alle tecniche da MOF per le salse, imperfettibili”.

“Io però mi sentivo pronto per fare la mia cucina. Avevo un quaderno su cui avevo appuntato tutto, ricette e concetti. E una formazione ormai a 360 gradi. È successo che alla Réserve, un hotel di Ginevra, lo chef si è rotto il ginocchio e a 27 anni mi sono ritrovato con 18 cuochi sotto di me. Facevamo una cucina mediterranea che era piaciuta alla critica, tanto che la Michelin ci aveva promesso la stella. Il risultato qual è stato? Che siamo stati tutti licenziati. Una delusione fortissima, quando il premio per cui avevo sempre lottato sembrava finalmente a portata di mano. Allora ho iniziato a lavorare da freelance, come chef privato di famiglie agiate, e ho conosciuto un imprenditore italiano, che mi ha proposto il ruolo di chef executive per un gruppo internazionale, una catena di cinque ristoranti italiani con sedi in tutto il mondo. Il mio compito era mettere a punto le ricette da sottoporre agli artigiani e a cuochi non qualificati, che accettassero il salario minimo. Quindi agivo anche da formatore. Personalmente mi interessavano gli aspetti gestionali, come far guadagnare un ristorante con una cucina corretta, amministrando i costi del personale e della materia prima. Ma lo sforzo era troppo, mi stavo ammalando e il dottore, quando vide i valori del sangue tutti sballati, mi prescrisse un mese di riposo. Al momento di rientrare, scoprii che tutto il mio lavoro era stato confiscato. E infine sono stato licenziato”.

“La delusione era tanta. Mi sono preso un anno di pausa per smaltirla. Ho capito che era tutto sbagliato, che non si poteva lavorare tutto il giorno per inseguire un’ambizione, distruggendo la propria vita; che non dovevo cambiare lavoro ma come lavoravo. No ai cuochi che urlano, perché lo stress è nemico della buona cucina. Con questo spirito sono tornato a Ginevra a studiare management, gestione delle risorse umane, leadership. Ho creato diversi progetti con altrettanti business plan da presentare a possibili investitori. Finché ho ritrovato Dominique Mottas, già socio della Réserve, che aveva creato due catene di ristoranti collegate ad Arthur’s Cellar, cantina di affinamento internazionale: Wine & Beef e Arthur’s, con Senderens e poi col suo secondo”.

“Da agosto 2018 seguo entrambi. Nei due indirizzi di Wine & Beef serviamo hamburger, entrecôte, carpaccio, tartare. Piatti molto semplici, con costi minimi, senza bisogno di cuochi, sostituiti da ‘garçon d’office’. Mentre da Arthur’s a pranzo c’è una cucina italiana gastronomica per la clientela business, nel quartiere delle banche, e la sera il cocktail bar con la musica dal vivo per un pubblico di giovani, che hanno voglia di far festa stappando vini importanti. Stiamo lavorando per aprine un altro, sempre a Ginevra: abbiamo già trovato la location, 600 metri quadrati per 35mila franchi al mese e 6 milioni di investimento, ma l’inaugurazione prevista per il mese di settembre ovviamente è slittata. Serviamo piatti come il filetto alla Rossini e la porchetta di maialino, una cucina tradizionale rivisitata, stagionale, leggera e gustosa, influenzata dalla Francia e dai prodotti locali. Perché come dice Iginio Massari, il genio stupisce con la semplicità. Di netto alla fine arriviamo al 16%, quando nel fine dining praticamente non c’è margine. E i miei cuochi, che lavorano 10 ore, hanno due giorni liberi alla settimana. La lezione resta quella di Sirio Maccioni: per avere successo bisogna cucinare per il cliente, non per l’ego del cuoco. Qualcosa di semplice, che la gente abbia voglia di mangiare una volta alla settimana, non una volta nella vita. Voglio clienti che si affidino a me, senza nemmeno prendere in mano il menu”.