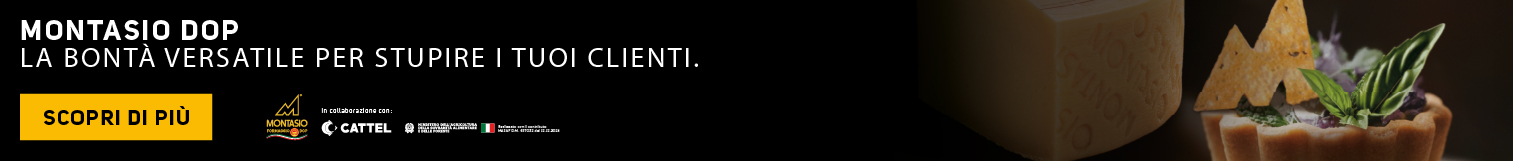“Da come la descrivono, sembra che la ristorazione sia il peggior settore del mondo. Non capisco questo accanimento, è eccessivo”.
L'opinione
Nel vivace universo della ristorazione, dove padelle e cuori s’infiammano con la stessa intensità, Alberto Chicote ha scelto di metterci la faccia – e la voce – per difendere un mestiere spesso più frainteso che celebrato. Con la sua consueta schiettezza e un sorriso che sembra uscito direttamente dalla linea di fuoco dei fornelli, lo chef madrileno ha preso parola nel podcast Se me antoja, come racconta La Vanguardia, regalando un’ode sincera e appassionata al mondo dell’hospitality. Peccato che, nel tempo dei social, anche un elogio possa trasformarsi in un campo minato. «Chiunque entri nel mio ristorante (riferito a clienti e dipendenti, ndr) non lo fa per altro che per divertirsi, divertirsi e ancora divertirsi». Un mantra ripetuto da Chicote con lo stesso entusiasmo con cui un maître versa champagne nelle flûte la sera di Capodanno. Eppure, quella che voleva essere una celebrazione della bellezza del servizio si è presto trasformata in un caso mediatico, tra cuori accesi e commenti al vetriolo.

Nel cuore di Madrid, nel suo ristorante Omeraki, Chicote sostiene di vivere circondato dalla felicità. Non quella edulcorata delle pubblicità, ma un sentimento tangibile che – a suo dire – si respira a ogni servizio. «Quando esco a salutare i tavoli e vedo che tutti si sono divertiti, è qualcosa di meraviglioso», racconta. Per lui, la cucina non è solo sudore e adrenalina, ma anche e soprattutto la costruzione di un momento felice, una parentesi di piacere condiviso tra chi serve e chi viene servito. L’ospitalità, nella visione di Chicote, è quasi una forma d’arte scenica: il cliente è spettatore e protagonista, e lo staff il cast invisibile ma essenziale di questo spettacolo quotidiano. Al tempo stesso, la sua non è certo una negazione delle difficoltà del mestiere. In fondo, ha esordito proprio citando la valanga di commenti negativi che spesso piovono sul settore: turni infiniti, paghe basse, burnout. «Sembra che siamo la peggiore attività commerciale del mondo, e non lo capisco», dice. La sua è una difesa d’orgoglio, un voler ridare dignità e valore a una professione che, sì, può essere estenuante, ma è anche capace di generare emozioni uniche.

Tuttavia, appena le sue parole sono state rilanciate su Instagram dal profilo del podcast, la sezione commenti si è trasformata in un’arena di confronto (e scontro). Il nodo, in fondo, è uno solo: è davvero possibile parlare di gioia e leggerezza in un settore che spesso impone turni massacranti, condizioni precarie e un riconoscimento economico che non sempre rispecchia l’impegno? «Con tutto il rispetto, ma non capisco cosa c’entri lavorare così tante ore con l’obbligo di uscire a intrattenere i clienti», scrive un utente, centrando il punto su una delle tensioni più delicate della ristorazione contemporanea: quella tra passione e fatica, tra dedizione e diritto al riposo. Un altro aggiunge con amarezza: «Dopo 12 o 14 ore, il cameriere o il cuoco non sono circondati da felicità, ma da unto, sudore e tavoli da sparecchiare». In effetti, la frase di Chicote, per quanto benintenzionata, sembra sottovalutare – o quantomeno sfumare – la fatica fisica e mentale che questo mestiere comporta. E forse è proprio qui che il messaggio ha inciampato: nell’entusiasmo contagioso del cuoco, in molti hanno letto una sorta di leggerezza nei confronti delle fatiche quotidiane della brigata.

Va detto: Chicote non è nuovo a uscite forti. È noto per la sua franchezza e per quel modo tutto suo di mescolare ironia e determinazione, anche quando si tratta di dire cose scomode. Ma questa volta, forse, ha scelto parole che suonano più come un'utopia che come una fotografia della realtà. Non perché la sua visione sia falsa, ma perché è parziale. Racconta il suo ristorante, la sua squadra, la sua energia. Non tiene conto – almeno non apertamente – di tutte le storie meno fortunate, dove il divertimento è un privilegio raro e la felicità non è nel menù. Se si guarda oltre la polemica, il messaggio di Chicote ha un cuore nobile: restituire senso al termine "ospitalità". Non solo servizio, ma accoglienza, empatia, calore. In un’epoca dove anche il mangiare fuori rischia di diventare routine, Chicote rivendica l’importanza dell’esperienza, del legame umano tra sala e cucina, tra cliente e staff. Una visione che non dispiacerebbe a un Karlos Arguiñano, altro chef iberico che, tra una battuta e l’altra, ha detto: «Chi porta a casa questa tortilla non sa cosa sia l’amore».

Eppure, perfino l’amore – in cucina come nella vita – richiede equilibrio. Tra entusiasmo e rispetto, tra dedizione e diritti. Forse il vero insegnamento che possiamo trarre da questo scambio acceso è proprio questo: la ristorazione è un mestiere d’amore, ma anche di regole. E il divertimento può (anzi, deve) esserci, ma non come obbligo, bensì come risultato di un contesto giusto, equo, sostenibile. In un mondo post-pandemico, attraversato da crisi economiche e cambiamenti culturali profondi, il mestiere dell’ospitalità deve sapersi reinventare. Non solo per sopravvivere, ma per tornare a essere desiderabile, rispettato, e magari persino invidiato. Le parole di Chicote, con tutta la loro imperfezione, ci ricordano che vale la pena parlarne. Vale la pena cercare un nuovo equilibrio tra cuore e portafoglio, tra vocazione e benessere. Vale la pena, insomma, continuare a cucinare sogni – ma senza dimenticare che anche chi li serve, ha il diritto di viverne uno.